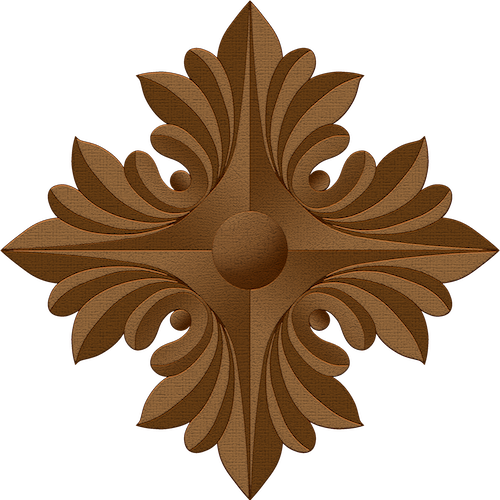di Bianca Silvestri
di Bianca Silvestri
Quando penso alla mia infanzia è con gioia che mi si presenta l’immagine della chioma di un albero di Giuda gigantesco dalla scorza nerastra su cui un rosa ciclamino esplode con vitalità per annunciare la primavera.
Il paese era disastrato, dopo la seconda guerra mondiale. Molte famiglie erano restate senza casa. Nella villa dove vivevo, si era formata una strana comunità. In ogni stanza della casa ci viveva una famiglia di sfollati. Gli uomini erano spesso assenti, in cerca di lavoro, per ricostruire un paese distrutto dalla guerra. Noi bambini giocavamo in un immenso giardino divenuto il fantasma di se stesso. Ci si trovava di tutto dai calcinacci, ai pezzi di ferro, alle finestre divelte, alle panchine di marmo spezzate, per non parlare delle bombe a mano che ci divertivamo a gettare nel pozzo con l’incoscienza che solo l’infanzia può avere. Un giorno il sindaco fece addirittura evacuare tutto il paese, perché avevamo trovato una bomba aerea inesplosa.
Ma a parte i pericoli corsi, che solo ora percepisco, la vita in quel giardino scorreva tra giochi e curiosità.
Nei pomeriggi primaverili ed estivi, attendevo l’ora in cui le donne, libere dai lavori domestici, si radunavano all’ombra dell’albero di Giuda per lavorare a maglia o per ricamare. Era il momento della giornata che preferivo, perché mi piaceva spiarle. Per lo più spettegolavano o raccontavano i loro segreti di donne, spose e madri. La parola si liberava come pioggia che cade su un terreno arido, avido di berla.
Un giorno una mia compagna di giochi, visto il mio interesse per i discorsi di quelle donne mi mostrò come poterli ascoltare senza essere viste. La folta chioma di quel meraviglioso albero toccava il terrazzo della sua stanza. Così prendemmo l’abitudine di scivolare silenziose sui rami. Nascoste dal fogliame abbondante, restavamo ad ascoltarle per ore.
Un fatto in particolare colpì la mia immaginazione di bambina ed ha impiegato una vita per essere rielaborato, tanto l’ambiguità del male che conteneva mi feriva e mi lasciava perplessa.
L’INNOCENZA DEL MALE
Dina e Rina erano due sorelle. Abitavano nella casa dei genitori. Non avevano conosciuto altro nella vita che quella casa e la strada che portava alla loro vigna. Ancora in fasce la mamma le metteva all’ombra del noce mentre si occupava dei lavori della campagna. Man mano che crescevano le insegnava a lavorare l’orto, a potare la vite e il ritmo delle stagioni che scandiva la successione dei lavori.
Restate orfane molto giovani, continuarono a vivere nel solo modo che avevano conosciuto.
Rifiutarono tutte le offerte di matrimonio. L’una non voleva lasciare l’altra, né la casa, né la vigna. Un uomo le avrebbe portate via, allontanate o, peggio ancora, si sarebbe intromesso tra loro, avrebbe profanato la casa, avrebbe comandato sulla vigna.
Diventate anziane, erano ancora insieme, facevano tutto insieme. Avevano finito per parlare da sole, come se parlassero all’altra, tanto si erano identificate. Legate da un segreto, da una colpa che cercavano di rendere innocente.
Era il 1944. Avevano paura di uscire in strada. In paese c’erano più macerie che case. Le strade erano deserte. Si udiva solo il passo cadenzato delle pattuglie dei tedeschi. Gli alleati, sbarcati ad Anzio, facevano continue incursioni aeree. La paura era palpabile. C’era il coprifuoco, i bombardamenti, le sirene, le grida, gli spari anche in pieno giorno. Le due sorelle non andavano ai rifugi, per non lasciare incustodita la casa. C’erano stati dei saccheggi durante i bombardamenti.
Ma ogni tanto andavano alla vigna, all’orto poco lontano dal paese, giù alla Selva. I lavori non potevano attendere. Dovevano raccogliere quello che avevano seminato, per mangiare, per venderlo. Allora uscivano, all’alba. Il fucile da caccia del padre nascosto sotto il vestito. Camminavano senza parlare, tenendosi per mano. Facevano in fretta quello che dovevano fare, nascondevano il raccolto dell’orto in sacche appese sotto il grembiule da lavoro, e tornavano com’erano venute. Non salutavano mai nessuno, camminavano a testa bassa.
Quello che accadde un giorno, fu il segreto che le unì e le divise per sempre.
Quel giorno, all’inizio del viottolo, tra la vigna e l’orto, si fermarono interdette. Sull’albero di noci c’era qualcosa. Una sagoma accoccolata, una divisa militare. Dina tirò fuori il fucile. Guardò la sorella, paralizzata dalla paura come lei. Restarono un eterno momento nell’indecisione. La sagoma sull’albero non si mosse. Rina toccò la mano della sorella. Dina puntò e sparò.
Lo sparo le fece trasalire. Si guardarono intorno. Un pensiero passò fulmineo nelle loro teste: se ce n’è uno ci saranno anche gli altri. Si rifugiarono nel capanno. Pallide e tremanti attesero spiando dai pertugi. Udirono il rumore leggero del vento tra le fessure, il cinguettio degli uccelli, lo sgocciolare ossessivo dell’acqua della fonte mentre fissavano quel corpo inerte, imprigionato tra i rami dell’albero, che gocciolava sangue all’unisono con l’acqua della fonte. L’urlo delle sirene lontane le destò. In un tacito accordo, presero pala e piccone, uscirono dal capanno. Picconarono e spalarono la terra con l’abilità e la perfezione che mettevano nei lavori dell’orto e della vigna. Scavarono una profonda buca. Ebbero un attimo di turbamento. Ma erano contadine, abituate a fare più che a pensare. Bisognava nascondere quel corpo. Bisognava evitare rappresaglie. Si avvicinarono decise, sicure di fare la cosa giusta. Ma ebbero il torto di guardarlo in viso. “Dio, com’è giovane!” fu l’unico pensiero che attraversò la loro mente.
Da quel momento tutto divenne più faticoso. L’ombra del dubbio cominciò a scavare gallerie sotterranee nel loro cervello. Ma sul momento agirono in fretta, decise. Lo calarono dall’albero con uno strattone del rastrello come facevano per i frutti che non volevano cadere. Lo trascinarono per le braccia. Lo fecero scivolare nella buca. Rimisero la terra. Appiattirono, rastrellarono. Tolsero ogni traccia. Prolungarono l’orto fin sulla tomba. Ma non raccolsero mai i frutti di quella parcella.
“Era già morto quando gli ho sparato, altrimenti ci avrebbe sentite”. Diceva Dina parlando da sola mentre spolverava la madia. “Se Dina non avesse sparato, avrebbe sparato lui”, rifletteva Rina mentre sbucciava le patate. C’era la guerra, bisognava difendersi. Abbiamo avuto coraggio. Siamo state bave. Nessuno ha mai scoperto il nostro segreto. Nessuno è mai venuto a cercarlo. Che cosa faceva sul nostro noce? Forse ci rubava le noci. Forse osservava i movimenti del nemico, laggiù all’orizzonte. Forse le raffiche di un caccia americano lo hanno ucciso. Nessuno è venuto a cercarlo. Dov’erano i suoi compagni? I tedeschi erano ancora da per tutto. Non si erano ancora ritirati. L’avranno dato per disperso, per disertore…. Forse, si era addormentato. Per questo non ci ha sentite. Ci avrebbe violentate e poi uccise. Se non gli avessimo sparato noi avrebbe sparato lui”.
Passavano le giornate a pulire la casa già brillante di cera, a cucinare, a cucire, a ricamare. Erano talmente abituate l’una a l’altra che si capivano senza parlare. Le loro abitudini con il passare degli anni divennero manie. Il silenzio s’installò tra loro. Quella tomba divenne talmente presente da impedire qualsiasi altro pensiero. Finirono per parlare da sole, un interminabile soliloquio per rendere innocente quella morte.
Non andarono più alla vigna. Avevano bisogno di denaro ma non vollero mai venderla. Come spiegare agli altri quello che era accaduto, se avessero scoperto quel corpo?
“Se Rina non mi avesse toccato la mano io non avrei sparato” si ripeteva Dina durante le ore d’insonnia, “è lei che mi ha spinta a farlo… l’ ho difesa… aveva paura… sono la sorella più grande… la mamma in punto di morte me l’ ha affidata… cosa dovevo fare? E poi, sicuramente era già morto…”.
Dormivano nel letto dei genitori. L’una accanto all’altra. Nel sonno Rina parlava, come contrappunto alla sorella. “Dina non doveva sparare. Quel povero giovane, avrà avuto una fidanzata che forse ancora l’aspetta o dei genitori che non sanno dove è finito. La colpa appartiene a Dina, io l’ ho solo aiutata, non potevo farla incolpare, erano tempi difficili, ognuno per sé, nessuno ti aiutava, ognuno cercava di salvare la propria pelle, non c’erano più né legge né controllo, per un pezzo di pane si uccideva… lei l’ ha fatto per paura, per salvarci… eravamo due ragazzine allora, io avevo quindici anni e Dina diciotto… troppo giovani, troppo sole per un tempo in cui i lupi sbranavano i lupi”.
Bianca Silvestri, si è laureata in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
E’ presidente della “Compagnia de l’Octagone”, gruppo formato da registi e attori di diverse nazionalità, con sede a Parigi, impegnati nella creazione artistica.
Bianca Silvestri ha pubblicato il romanzo Fermata a Little Venice (1997) per il quale ha ricevuto il premio “Autore dell’anno” e il premio internazionale “Emily Dickinson”.
Nel 2000 ha pubblicato la raccolta di racconti Il vento di sabbia.