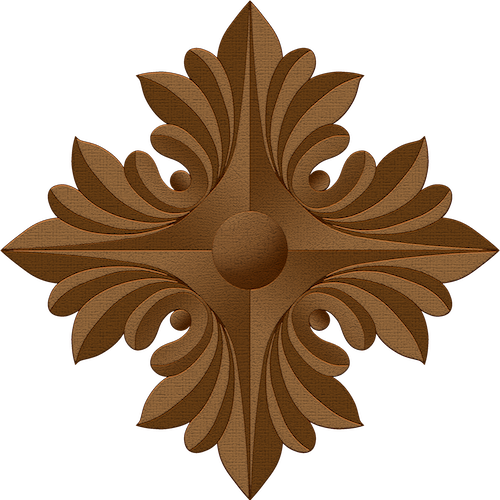di Ugo Onorati
di Ugo Onorati
Roma poggia su sette colli, mentre i Castelli Romani svettano su un numero doppio di alture, adagiati fra i Monti Albani e i Monti Tuscolani. Roma è una formosa matrona. I Castelli Romani sono al suo collo un filo di quattordici perle, tutte preziose per la storia e l’arte che qui brillano da secoli per l’inseparabile lavoro fatto insieme dalla natura e dall’uomo.
Ogni Castello ha una sua propria fisionomia: dall’impronta dell’abitato cresciuto intorno al rispettivo castrum all’identità culturale di ciascuno, che può vantare un dialetto, una festa patronale, una peculiarità culinaria, un monumento, un personaggio famoso, un carattere tipico della gente del luogo. L’Urbe li tiene avvinti a sé con antichi cordoni ombelicali: la via Appia, la via Latina e la via Tuscolana. Flusso arterioso i carretti a vino, flusso venoso i fagottari della domenica. Pittoreschi i luoghi, fervidi i vini, campagnola e casereccia la cucina. Fra pianura e monti si contendono lo spazio i frutti: uva, fragole, castagne, con i fiori: gladioli, narcisi, violette.
Sull’esempio di Lucullo e di Cicerone, papi, imperatori e principi vi fecero crescere prima la vigna e poi la villa. Fu così che un’illustre prosapia: Frangipane, Orsini, Colonna e Savelli, quindi Aldobrandini, Ruspoli, Chigi, Torlonia, Sforza Cesarini e Borghese rinnovarono nel medioevo e in età moderna i fasti e il potere delle gentes romane nelle ville imperiali. Per ultimi i viaggiatori inglesi, tedeschi e francesi, poeti ed artisti, italiani e stranieri, ne descrissero il romantico intreccio di edere e ruderi. Luogo di ottobrate del generone villeggiante nell’ottocento, fra Belli e Pinelli; luogo di scampagnate domenicali del popolino giolittiano (impiegati, operai e minenti “lavannare”) assatanato consumatore di vino e porchetta, nel novecento fra Pascarella e Trilussa; luogo – infine – del consumo autarchico di sagre paesane per le masse del dopolavoro fascista intruppate su tram e treni, fino al dopoguerra. Poi nulla. Fu allora che il luogo dello spirito, divenuto nel frattempo dello stomaco, cedette negli anni sessanta del secolo scorso all’effimera fama delle ville di attori e cantanti e alle orde affamate dei transumanti automobilisti domenicali. Finché all’insegna dell’”hic manebimus optime”, divenuto edificabile il terreno agricolo, una flotta selvaggia di seconde case e di case di necessità non presero il largo dai centri storici per navigare indisturbate nella Campagna Romana che né Ashby, né Lanciani riconoscerebbero più!
All’origine un gigantesco vulcano, cresciuto dal fondo del mare, dà vita alla Campagna Romana. Poi, stanco di brontolare, l’imponente edificio diventò nido di boschi e di laghi alloggiati fra alture collinari e profonde vallate. Immense macchie di querce, tigli, aceri dominavano allora il paesaggio, di cui oggi resta traccia nel parco Colonna di Marino e nel parco Chigi di Ariccia. Dei molti bacini lacustri, prosciugati col tempo dall’uomo, solo i due maggiori: l’Albano e il Nemorense guardano il cielo come due occhi azzurri. Le loro orbite si possono contemplare dalla sommità del monte Cavo, da dove lo sguardo si può spingere fino al mare che luccica all’orizzonte, come quel giorno che Enea vi approdò esule in cerca di fortuna. Solo più tardi arrivarono le ninfe, al seguito di nomadi pastori ariani, attratti dal clima mite e salubre, dall’abbondanza di acque, di frutti spontanei, di selvaggina e di pesce lacustre. Dalla pianura che dominavano, o da un eponimo mitico re, si diedero il nome Latini. Non poco dovettero combattere per farsi rispettare dai vicini di casa: Etruschi, Italici e Greci che, invidiosi della loro favorevole sorte, ne insidiavano casa e lavoro. Adoravano a tal punto la Luna, la luce penetrale dei boschi e quella riflessa sugli specchi d’acqua che dedicarono a Diana un tempio celebre in tutto il Lazio. Il culto lo affidarono a un re sacerdote che, armato di coltello, si aggirava truce per la foresta sempre pronto a difendersi da eventuali pretendenti, riconoscibili da un ramo d’alloro, svelto dal sacro recinto del tempio, sventolato come un’insegna. A un quadro di Turner: Il ramo d’oro del 1820 spetta il merito di aver prodotto nell’immaginario occidentale il fascino dello Specchio di Diana e del mito di Virbio reincarnato, ancor prima che a Frazer venisse l’idea di far nascere l’antropologia moderna, partendo proprio dal Nemus aricinus. Ad ammazzare per sempre il rex nemorensis non fu il cattolico romano Teodosio, ma molto prima il saltafossi Caligola che si tolse lo sfizio di subentrare per sempre in quella carica, diventando re di Nemi senza successori; lo stesso folle lucido che volle un tempio galleggiante sul ventre del lago, come sposo sempiterno di Diana.
Fra i più importanti santuari del Lazio, Lugli segnala quello di Giunone a Lanuvio, detta Salvatrice o Liberatrice (Sòspita) dai mali fisici, come pure da quelli della guerra e della fame. Una volta l’anno illibate fanciulle offrivano appetitose focacce a un grosso serpente rintanato nell’antro della dea. Se il rettile mangiava di gusto va bene: i raccolti sarebbero stati abbondanti; altrimenti la comunità avrebbe espiato sacrificando le non pie giovinette alla dea.
Il principale luogo di culto era quello di Giove sul monte Cavo, l’ Albanus, una specie di vetta sacra dei Latini, così come poteva essere l’Olimpo per i Greci. Questo era il centro religioso politico e culturale di tutte le città federate nella Lega Latina. Più di quaranta villaggi sparsi sui colli e sulla pianura fino al mare: Alba ne era la capitale, ma poi c’erano Aricia, Bovillae, Corilla, Labicum, Tusculum, Cynthianum, Lanuvium, Ferentum, Mugilla, Cabum, Corbium, solo per citarne alcuni che hanno mantenuto una continuità di luogo con gli attuali centri abitati dei Castelli Romani. I capi di queste città stato si riunivano una volta l’anno, durante le Ferie Latine, per dirimere i contrasti interni e per organizzarsi contro le minacce esterne. Alla fine delle discussioni, un toro bianco veniva sacrificato sull’altare di Giove padre (Iuppiter) e le carni cotte a puntino venivano distribuite in parti eque per dimostrare che tutti i popoli erano uguali di fronte al dio. Poi lungo la via Sacra discendevano ai piani boscosi, intorno alla sorgente della ninfa Ferentina e lì, dopo aver banchettato con le loro delegazioni in agape fraterna, assistevano ai giochi “olimpici” fra i campioni delle varie tribù, specializzati nelle gare di lotta libera e dell’altalena.
Ai margini di questa civiltà, anche geograficamente (il confine settentrionale dell’area laziale era considerato il corso del Tevere), erano i Romani che, per quanto si dessero nobili ascendenze latine: figli di Romolo, quindi nipoti di Ascanio e di Enea, furono sempre considerati un po’ i bastardi della famiglia, dei sanguemisto sabino ed estrusco, oltre che latino. Roma divenne tuttavia grande e potente, fino al punto di conquistare per primo il Lazio e poi di dare vita a un impero nel quale si diffuse la lingua latina e il culto dei principali dei laziali: Giove, Giunone e Diana. Tant’è che sul Campidoglio, come un nuovo monte Cavo, fu evocato il culto di Giove e riproposta la via Sacra, mentre sull’Aventino quello di Diana aricina e al Foro quello di Giunone.
Roma si appropriò del Lazio Antico definitivamente nel 383 avanti Cristo e l’area nei secoli successivi divenne il cortile di casa dei Romani: coinvolte le città latine nelle guerre civili furono devastate ora da Mario, ora da Silla. Poi i ricchi e i potenti ne fecero luogo di villeggiatura per gli ozi, impiantandovi imponenti ville che conobbero la fine della Repubblica e poi quella dell’Impero: quella di Clodio, fratello della Lesbia amata da Catullo, nei pressi della quale, sull’Appia, vicino Frattocchie, Milone portò a compimento il suo sanguinoso attentato; quella del grande Pompeo, proprio lì dove oggi sorge Albano, nella quale soggiornarono Tiberio, Caligola, Nerone, Caracalla e Settimio Severo, i cui spazi in età moderna i principi Doria trasformarono in villa; quella dell’imperatore Vitellio ad Ariccia; ma soprattutto quella di Domiziano, enorme, distesa dalle alture di Castel Gandolfo fino alle rive del lago, trattato come una vasta piscina dall’architetto dell’imperatore, da una cui porzione i Barberini trassero nel seicento una degna sede di villeggiatura per i Papi. Poi, sul versante tuscolano, quella di Passieno Crispo, marito di Agrippina, intorno alla quale, fra Bagnara e Vivario, crebbe come edera su ruderi il primo abitato medievale di Frascati; non furono da meno le ville di Gabinio, di Tiberio, di Galba, ma soprattutto di Lucio Licinio Lucullo, rimasto alla storia più per le raffinate cenette che vi imbandiva, che per le battaglie politiche o campali fatte insieme a Cesare. Vicino di casa, ma avversario in Senato, era quell’avvocato Marco Tullio Cicerone che, nella sua Tusculana villa, già proprietà di Lutazio Catulo, coltivava la filosofia per sé e per gli amici, disputando e riflettendo nei rari momenti di otium che la caotica Roma gli consentiva. Una fioritura di “seconde case”, dopo quelle di Roma, che l’aristocrazia romana riuscì, gareggiando con se stessa per prestigio e per dovizia, a far fiorire intorno al Tuscolo, oggi Grottaferrata, Marino, Colonna, Monte Porzio, Monte Compatri, i cui ruderi evocano i nomi e i fantasmi dei loro padroni: Augusto, Galba, Nerone, Nerva, Tiberio, Agrippina, Matidia, il proconsole d’Asia Marcello, Marco Porzio Catone, gli splendori e le trame di famiglie come i Quintili, i Vinici, gli Ottavi, per finire in territorio di Marino con Mamurra, favorito di Cesare, di Quinto Voconio Pollione, dei Valeri: Messalla e Paolino, rimasti curiosamente fusi nel toponimo “Messer Paoli”.
Ci pensarono le invasioni, le carestie e le pestilenze, concomitanti alla caduta dell’Impero romano, a mortificare tanta superbia e tanto sfarzo. Vandali e Goti tagliarono gli acquedotti e assetarono Roma, saccheggiarono le ville della Campagna Romana, dispersero gli abitanti di pianura. Questi si rifugiarono sulle alture dei colli, tra le mura degli antichi municipi un tempo decaduti, ma ora tornati in auge per il fatto di essere più difendibili e poi più salubri di fronte all’avanzare dell’impaludamento, dovuto al progressivo abbandono delle opere idriche nei fondi rustici. Il Cristianesimo si diffuse da subito e Mitra cedette a Cristo il primato del culto contemporaneamente a Roma: ce lo tramandano le catacombe di San Senatore ad Albano e quelle di San Zotico e di Decimo a Grottaferrata, come pure la comunità di Casa Rossa in territorio bovillense, fra Marino e Castel Gandolfo. Costantino donò alla chiesa di San Giovanni Battista di Albano vasti possedimenti imperiali che comprendevano non solo i castra albana di severiana memoria e la vasta villa di Domiziano, ma pure terreni, boschi, laghi e borghi compresi fra le vie Appia, Latina, Tuscolana e Labicana. Il territorio così costituito comprendeva da una parte gli attuali comuni di Genzano e di Nemi, dall’altra Marino e Rocca di Papa, da un’altra ancora i possedimenti fondiari di pianura che si estendono fino al mare. Nacque così nel 465 la diocesi di Albano, la più antica fra tutte le suburbicarie di Roma. L’Albanum, così si chiamava il demanio imperiale donato dall’imperatore alla Chiesa, godeva pure del privilegio di non essere tosato a sangue dall’esoso esattore bizantino e la vita per le masse rurali era un po’ meno dura che altrove. Le scorrerie dei Longobardi, la peste, le inondazioni e le carestie provocarono un crollo demografico generale. Gregorio Magno prima e altri papi suoi successori poi curarono di ripopolare le zone per costituire una fascia di sussistenza alimentare e difensiva intorno a Roma. Anche la zona albana fu interessata dall’insediamento di corti e di masse e infine, dopo la conquista carolingia, di domusculte. Colonie agricole e villaggi rurali, di cui restano scarse tracce archeologiche, a causa delle ripetute distruzioni e spostamenti, che però preparano la rinascita demografica avvenuta dopo l’anno Mille. Come è accaduto per la città di Roma nell’alto medioevo, molte di queste realtà abitative hanno convissuto con il precedente sostrato di edificazioni, che offriva spazi chiusi, recinti murari, materiali di risulta per nuove edificazioni e cisterne per l’acqua. Così avvenne per Grottaferrata, dove l’abbazia fu costruita nel 1004 sulle fondamenta di una villa romana che qualcuno ritiene essere stata di Cicerone e nei cui anfratti aveva vissuto per secoli una minuscola comunità rurale raccolta intorno a un oratorio mariano: la Madonna de crypta ferrata; così fu pure per Albano, il cui centro abitato più volte incendiato e saccheggiato, risorse sempre all’interno delle strutture murarie dei castra severiana. Continuità e discontinuità nel tempo e nello spazio nell’uso di luoghi abitati ha caratterizzato l’area dei colli Albani e Tuscolani nei secoli dell’alto medioevo, ritrovandosi intorno a luoghi di culto, presidi stradali, alture difensive. Permanenza di toponimi poche, tranne forse per la Massa Pauli, oggi Messer Paoli, sorta sulla villa dei Valeri nel territorio di Marino, vicino all’Appia. In qualche caso ciò che rimaneva delle comunità abitanti le antiche città romane sopravvissute all’inondazione delle invasioni barbariche, come Boville, abbandonarono definitivamente il posto a seguito delle incursioni saracene nel IX secolo e si rifugiarono su più difendibili alture ripopolandole. Potrebbe essere il caso del castrum Marini, il cui nome soppianta intorno al Mille quello precedente di Castrimoenium. Tuscolo invece attraversa quasi indenne l’intero millennio per essere distrutta e non più ricostruita nel 1191 non dai barbari, ma dai romani e dalle truppe imperiali di Enrico VI. Fu così che gli abitanti superstiti andarono a valle per fondare o per ripopolare la località di Frascati.
La fisionomia dei Colli Albani e Tuscolani cambiò decisamente durante i primi tre secoli successivi all’anno Mille e tale rimase, quasi immutata, fino ai giorni nostri. Avvenne che con la stabilizzazione demografica e con lo sviluppo del potere feudale delle famiglie patrizie romane si andarono a costituire possedimenti intorno a Roma e più in generale nel territorio laziale. La Campagna Romana, già costellata di torri di avvistamento in funzione di difesa dalle incursioni piratesche, offrì il modello di sviluppo divenuto da quel momento dominante in tutta l’area: il castello. Messi alle strette fra parteggiare ora per l’imperatore, ora per il papa, le famiglie baronali romane degli Annibaldi, dei Caetani, dei Colonna, dei Conti, dei Frangipane, degli Orsini, dei Savelli, non si accontentarono di occupare i rioni di Roma, come avevano fatto in precedenza i Crescenzi e i Teofilatto, ma stabilirono avamposti nel territorio circostante, tali da costituire le loro basi di potere permanente, sia per controllare il pontefice romano di turno, sia per rifugiarvisi in caso di difficoltà. Da quel momento le alture dominanti, i punti nodali strategici del sistema viario furono caratterizzati dalla presenza di un castello, intorno al quale si sviluppò il centro abitato, vecchio o nuovo che fosse. Da queste costruzioni difensive deriverà poi il nome di Castelli Romani. L’incastellamento feudale realizzato su spazi ristretti, nonché la vicinanza del potere papale e la scarsa consistenza del tessuto sociale e produttivo non consentirono all’area di avviare un processo di sviluppo urbano alternativo, tale da consentire la nascita del libero comune, come in altre parti della Penisola, con l’unica eccezione di Velletri. Nonostante i castelli siano stati più volte guastati e ricostruiti, passati di mano in mano da una famiglia a un’altra; nonostante occorra andarli a individuare e riconoscere nell’attuale tessuto urbano, trasformati all’inizio dell’età moderna in palazzi patrizi, restano pur sempre lì a caratterizzare i centri storici delle vivaci cittadine del territorio Albano – Tuscolano non tanto con le loro torri merlate, quanto con le imponenti masse murarie, che testimoniano un passato terribile fatto di interminabili guerre e di assedi. Non tutti i castelli hanno dato vita a un centro urbano, come quello di Borghetto, isolato rispetto a Grottaferrata, o raso al suolo come quello di Molara sulla via Anagnina lontano da Frascati e da Rocca Priora. In altri casi sullo stesso centro abitato, come Marino, insistono più castelli di epoche e famiglie diverse: quello dei Conti di Tuscolo (Castelletto), quello dei Frangipane (Rocca), quello degli Orsini – Colonna (palazzo Colonna). Questo periodo, che durò circa cinque secoli, diede vita a borghi recintati da mura, abbarbicati su alture difese naturalmente da dirupi, con un sistema viario asfittico e un affollamento di case basse scure collegate da scalinate e rampe per superare le diverse quote di livello. Qua e là svettano delle case torri sull’abitato. Gli edifici sono privi di intonaci e offrono alla vista la struttura di sassi di tufo o di selce con cui sono stati costruiti. Il colore è generalmente grigio. Piccole finestre e porte non larghe caratterizzano il fronte delle case. Postierle e scarpate e contrafforti si presentano al viaggiatore che si accosta al borgo per accedervi. I vicoli fra casa e casa sono corti e stretti, spesso non vi penetra luce, se non a mezzogiorno. Questo è l’aspetto dell’abitato che ancora si conserva in larga parte nei centri storici dei Castelli Romani, che ancora oggi possiamo osservare e che apprezziamo come turisti, o come nostalgici amanti del passato, ma la vita non doveva essere molto comoda, per la mancanza di igiene, per le epidemie ricorrenti, per la penuria di mezzi che procuravano freddo e fame per gran parte dell’anno. Quando poi non c’erano assedi e guerre che facevano precipitare ancor più la situazione.
Il paesaggio urbano, la composizione sociale e il territorio cambiarono considerevolmente dalla metà del Cinquecento in poi. Il ritorno dei papi da Avignone e quindi i contrasti fra Camera Apostolica e patriziato feudale, abituato a spadroneggiare su Roma e Campagna, risoltisi non senza lunghe e aspre lotte con un assoggettamento del secondo alla prima, fece sì che lo Stato ecclesiastico si consolidasse sempre più in forma centralizzata, come un qualsiasi principato della Penisola. L’avvento delle armi da fuoco, in particolare dell’artiglieria, rese inservibili manieri, torri e castelli, che furono abbandonati, o trasformati in palazzi principeschi. Mentre la Camera Apostolica può disporre dei titoli di assegnazione dei feudi a questa o a quella famiglia, agli antichi feudatari non resta che assoggettarsi, o resistere con milizie armate sempre più costose per numero e per equipaggiamento. Il territorio inizia ad essere sfruttato sempre più intensamente intorno ai centri abitati, sorti intorno al castello, per ricavarne materie prime e prodotti che consentano la massima autosufficienza possibile all’interno dello stato feudale. Le conseguenze sono che i borghi medievali straripano oltre le mura tradizionali di difesa, per fare spazio alle nuove famiglie immigrate di artigiani e di operai, ma anche per rispondere alla crescita demografica di tutta l’area a partire dalla metà del Cinquecento. Gli effetti sono che si disboscano antiche selve per fare posto a pascoli, a coltivazioni di foraggio e cereali, ortaggi, canapa, ma soprattutto olivo e vite, il cui vino è prodotto pregiato continuamente richiesto dalle osterie di Roma. Così, tranne qualche ampia forra preservata dal taglio, perché destinata a riserva di caccia (parco Colonna a Marino e parco Chigi ad Ariccia), tutta la precedente foresta di querce, tigli, aceri che dominavano il paesaggio da oltre trentamila anni, scomparve nel giro di mezzo secolo, sostituita per lo più dal castagno più rapido a crescere, utile all’edilizia, all’agricoltura e alla tavola dei più poveri. Nei centri abitati dei Castelli nascono nuovi assi viari con lunghe ali di caseggiati che accolgono come nuova zona residenziale il generone del luogo; mentre il popolino resta confinato nel rione medievale intorno al castello. Così pure alla crescita numerica della popolazione corrisponde l’edificazione di nuove chiese, ancor più che il restauro e l’ampliamento delle vecchie. Il territorio poi si costella di casali colonici in seno a grandi possedimenti fondiari nobiliari per ospitare masse di braccianti immigrati, mentre i vignaioli locali, che possiedono poca terra per la sussistenza della propria famiglia, continuano come nei secoli precedenti a risiedere nel borgo medievale e a raggiungere giorno per giorno il loro appezzamento. Nascono o si rafforzano gli usi civici per consentire alle famiglie proletarie di sopravvivere con la coltivazione di ortivi, di pascolare, o di raccogliere legna. Attività imprenditoriali sono limitate e soggette al permesso del Padrone, così è chiamato il principe del luogo, che comunque si riserva il monopolio dei forni, della macina del grano, del commercio del sale e di altre privative. Solo lui vede e provvede ai bisogni dei sudditi, come un padre. E come un padre amministra la giustizia, seguendo leggi e consuetudini del luogo. Ogni castello, o possedimento feudale che accorpa più castelli, ha il suo statuto, le sue unità di misura, gli obblighi connessi alla manutenzione di strade, ponti e acquedotti. Anche la Chiesa ha localmente una sua struttura economica autonoma e chiusa, fatta di censi, di rendite derivanti da proprietà di vigneti, canneti, cantine e case. Scarsa è la comunicazione fra le popolazioni dei singoli castelli che, nel corso dei secoli, ha prodotto significative differenze linguistiche fra luogo e luogo, fino al punto di caratterizzare ciascuno dei centri abitati con un peculiare e riconoscibile dialetto.
Con la riorganizzazione del territorio voluto dalla Camera Apostolica e con la sostituzione progressiva delle antiche casate feudali nel possesso dei castelli a beneficio di nuovi padroni legati alla corte pontificia (Borghese, Chigi, Doria e Torlonia al posto di Orsini, Savelli e Colonna) avviene tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento anche per i Castelli Romani una fioritura di restauri di chiese e palazzi, ma soprattutto della creazione di nuove ville patrizie per cui sono impegnati i migliori architetti e artisti attivi a Roma. Nel corso del Rinascimento e poi nella stagione del Barocco i Castelli Romani sono avvertiti sempre più come un luogo dello spirito per le grandi presenze e testimonianze provenienti dall’antichità classica. Papi e Principi sempre più colti e raffinati si comportano come i Romani della fine della Repubblica e dell’inizio dell’Impero: spostano la loro attenzione e trasferiscono qui il loro sogno di otium e di ricreazione. Frascati è la prima fra le città dei Castelli a vivere la stagione delle grandi ville, sottratta ai Colonna dalla Camera Apostolica che vi proietta da Roma stile di vita e impronte culturali da corte principesca. Incominciano i Farnese che attraverso papa Paolo III, loro famigliare commissionano la villa Rufina ad Antonio da Sangallo, poi di Frascati fanno sede di villeggiatura estiva, quindi è la volta di villa Aldobrandini decoro e sfoggio principesco di Pietro, cardinal nipote di Clemente VII, poi ancora di villa Mondragone, centro mondiale di formazione dei Gesuiti. Anche le tradizionali famiglie baronali, ancorché coperte di debiti, iniziarono a gareggiare con la Camera Apostolica e con la curia pontificia per migliorare il territorio dei loro stati e ad arricchire i loro castelli di nuove chiese, ville, palazzi e opere d’arte. Per Marino i Colonna ingaggiarono: Antonio da Sangallo il Giovane per trasformare in palazzo il loro castello, quindi Girolamo Rainaldi per sistemare i Giardini del Paradiso e il Barco, Antonio Del Grande per progettare la collegiata di San Barnaba, Domenico Fontana per disegnare la nuova piazza di Borgo delle Grazie e Giuseppe Sardi per realizzare la chiesa del SS. Rosario e infine le ville: Belpoggio, Baldacchini. Per Castel Gandolfo i Barberini, succeduti ai Savelli, affidarono a Carlo Maderno la trasformazione del castello nel palazzo che sarebbe stato poi per sempre la residenza estiva dei romani pontefici, a Gian Lorenzo Bernini il progetto della chiesa di San Tommaso di Villanova. Per Ariccia i Chigi, succeduti anche qui ai Savelli, grazie alla loro disponibilità finanziaria di banchieri, chiamarono il Bernini prima per restaurare la chiesa della Madonna di Galloro, poi per un progetto molto più impegnativo: la nuova collegiata dedicata alla Vergine Assunta in cielo, un piccolo gioiello di architettura che conclude lo spazio di corte antistante il castello Savelli, divenuto nel frattempo palazzo Chigi ad opera di Carlo Fontana. A Grottaferrata l’abate commendatario Odoardo Farnese affidò nel 1608 al Domenichino il compito di decorare con un ciclo di affreschi la cappella dedicata ai santi fondatori Nilo e Bartolomeo, per illustrare la storia dell’abbazia: uno dei capolavori da menzionare di tutta l’arte del Seicento. Carlo Rainaldi progetta per il cardinale Scipione Borghese la chiesa dell’Assunta a Montecompatri realizzata nel 1633 e la ricostruzione della chiesa di San Gregorio Magno a Monte Porzio Catone, avvenuta nel 1666 per volontà di Giovanni Battista Borghese. Così la singolare sistemazione urbanistica di Genzano a ventaglio sull’Appia, con le sue caratteristiche olmate, voluta dalla famiglia Cesarini succeduta ai Colonna, e il duomo della SS. Trinità dedicato a San Tommaso da Villanova opera di Pietro e Giovanni Peronese.
La riapertura dell’Appia alla fine del Settecento e altre opere pubbliche portate a termine dallo Stato pontificio fino alla prima metà dell’Ottocento non valsero a procurare in significativo sviluppo all’area dei Castelli che rimase socialmente ed economicamente depressa fino alla unificazione dello Stato italiano. Tuttavia i luoghi esercitarono un fascino particolare per i viaggiatori italiani e stranieri che, per più di un secolo, giunti a Roma, visitavano anche i Castelli Romani prima di recarsi nel Mezzogiorno. Era il periodo del Gran Tour una sorta di pellegrinaggio culturale e spirituale sulle orme delle grandi civiltà del passato. Artisti, poeti, letterati, musicisti valicavano le Alpi per conoscere da vicino l’Italia, attratti dai paesaggi, dalla storia, dai monumenti e riscontrare dal vivo ciò che i testi classici raccontavano. Al fascino romantico e decadente dei ruderi coperti di verdure si aggiungeva la scoperta di una società arretrata, rispetto a quella europea contemporanea, e il contrasto stridente fra le classi patrizie che si annoiavano in palazzoni semivuoti e masse di pastori, di contadini, di tuttofare, superstiziose e quasi abbrutite. Le paludi malariche, i briganti, la desolazione di una campagna brulla e spopolata intorno a Roma era motivo di attrazione per qualcuno e di riflessione sui grandi cicli della storia, della natura, dell’arte e dell’uomo per altri.
Dalla parola francese “tour” deriva quella italiana “turista” e il primo turista che ci piace ricordare è Charles De Brosses che giunge con una delegazione a Roma fra Sette e Ottocento. Pervaso dal mito dei luoghi classici a proposito di Grottaferrata commenta: “È l’antico Tusculum di Cicerone, il cui posto è stato preso indegnamente da certi frati dell’ordine di San Basilio”. Piuttosto freddo di fronte alle ville tuscolane, De Brosses prova meraviglia soltanto per la fontana del Belvedere di villa Aldobrandini a Frascati, di cui deplora la musica meccanica azionata dai getti d’acqua. Lo spocchioso francese ricorda di aver mangiato “nougat pétri au miel”, cioè miele impastato a farina acqua e nocciole: chissà che non sia stato l’antenato della pupazza frascatana! A Castel Gandolfo minimizza perfino sulla villa pontificia e sui magnifici giardini all’italiana, ma il suo nazionalismo cede di fronte allo spettacolo del lago di Nemi che lo ammalia nel ricordo dei riti misteriosi accaduti venti secoli prima intorno allo Specchio di Diana. Antoine Jean Baptiste Thomas, pensionnaire du roi à l’Académie de France à Rome fa una puntata a Genzano nel 1816 per incrementare la sua raccolta di litografie sui costumi e sulle feste sacre o profane nello Stato pontificio e in Un an à Rome et dans ses environs descrive l’Infiorata di Genzano: « Le jour de l’octave de la Fête-Dieu … à Genesano, petite ville au bord du lac de Némi, une procession solennelle s’avance sur les tapis de fleurs artistement préparés et composés principalement de dessins d’armoiries. De chaque côté des rues, s’élèvent des piquets entourés de feuillage et auxquels son suspendues des guirlandes de fleurs » . Anche Ferdinand Gregorovius, lo storico di Neidenburg autore di una monumentale storia di Roma nel medioevo, descrive l’Infiorata di Genzano, dove si reca il 5 giugno 1864: “Nel mosaico floreale sono raffigurati emblemi e stemmi, sempre con meravigliosa abilità” e l’anno successivo, attraversando la boscosa ‘galleria’ fra Castel Gandolfo e Albano dichiara: “Da per tutto si risvegliano in me scene del passato, tutti quei luoghi erano popolati da apparizioni”. Intorno al 1829 lo statunitense Samuel Finley Breese Morse, prima di diventare l’inventore del telegrafo, coltivava interessi artistici e per questo visitò anche l’Italia. A proposito dell’Infiorata riferisce: “Il selciato della strada tra i pilastri in entrambe le strade e per una distanza di almeno mezzo miglio era squisitamente decorato con fiori di vari colori simile ad un immenso tappeto dai magnifici disegni”. E infine lo scrittore russo Nikolaj Gogol: “immaginatevi tutte le vie della cittadina ornate e coperte di fiori. Ma non crediate che i fiori siano semplicemente gettati alla rinfusa per la strada. Niente affatto. Non direte neppure che sono fiori, penserete a tappeti variopinti e istoriati stesi per terra. Tutti i motivi sono eseguiti in petali differenti: stemmi, vasi, disegni svariati e perfino il ritratto del papa. Una cosa straordinaria. Tutte le case, le finestre, le porte, tutto era pieno di gente. Su tutti questi fiori doveva passare la processione che collegando le due chiese doveva fare il giro di tutto il paese”. Vicino a Genzano il lago di Nemi ha sempre suscitato un’attrazione magnetica su molti viaggiatori, per tutti vale la testimonianza del poeta romantico inglese George Gorgon Byron: “Ecco Nemi, incastonato tra i monti boscosi così profondamente che il vento sradicatore che strappa la quercia dalle sue radici e fa riversare l’oceano oltre i suoi confini e ne trasporta la schiuma fin contro i cieli, risparmia suo malgrado lo specchio ovale del suo lago cristallino e calma come odio covato, la sua superficie presenta un aspetto profondo e freddo e posato, che nulla può scuotere, tutto raccolto in se stesso e in cerchio come una serpe che dorme”. Della città natale di Antonino Pio, di Licinio Murena, di Elio Stilone e di Marcantonio Colonna: Lanuvio scrive molte pagine l’archeologo inglese Arthur John Strutt: “La torre che difendeva l’angolo orientale della cinta di mura rifatta dai Colonna nel secolo XV è la più grande e imponente anche da lontano delle quattro torri circolari che anticamente difendevano i quattro angoli della terra baronale di Civita Lavinia”. Risalendo l’Appia incontriamo Ariccia insieme a Stendhal: “La più bella selva che esiste al mondo è quella di Ariccia. Grandi rocce nude e brune spuntano in mezzo alla più bella vegetazione e alle varietà più pittoresche di fogliame. Lo spettacoloso rigoglio di queste piante mostra che la montagna è un antico vulcano”. Albano ci viene raccontata dal narratore statunitense Washington Irving: “Di lì, mentre scendevamo lungo una delle strade di Albano si aprì dinanzi a noi la vista della Campagna di Roma. Il panorama è sommamente interessante sia per la sua autentica bellezza che per la cetena di idee che suscita. Quel vasto e bel tratto di campagna pianeggiante e diversificato da dolci pendii e declivi che producono le più belle linee ondulate: il manto verde, il mare da una parte e gli innevati Appennini dall’altra a delimitare la prospettiva. Nel mezzo l’occhio è attirato al luogo dove Rome her own sad sepulchre appears”. Castel Gandolfo ci viene presentata da F. J. L. Meyer: “Il lago non vi sorprenderà per la sua estensione ma le sue sponde ridenti e pittoresche sapranno attirarvi e trattenervi. L’occhio non può abbracciarne il contorno e scoprirne tutte le bellezze. La sua forma irregolare, la catena di colli che lo circondano e che producono un vino paragonato dagli antichi romani allo stesso Falerno, è interrotta dagli aggetti di grandi masse di roccia. Guardate questo lago nel momento in cui lo hanno sì spesso dipinto Hackert e Moore, il celebre paesista inglese; quando cioè i raggi dorati del sole al tramonto si fondono col colore verdastro delle acque e i vapori azzurri della sera, che si stendono sulla superficie del lago e sulle sue sponde, danno al quadro la tinta più armoniosa. Già cade sulle acque l’ombra della sera che ancora gli ultimi raggi illuminano la sommità delle colline e imporporano la piramide maestosa di Monte Cavo su in alto, in fondo alla scena”. Addentrandoci nel recinto tuscolano incontriamo Marino, per la quale scegliamo una citazione di Richard Voss: “Separata da Grottaferrata solo per mezzo di un profondo burrone, ecco l’altura ricca di vigneti magnifici, tra cui riposa Marino, la città di Vittoria Colonna, la città davanti alla quale si accampò Cola di Rienzo, ora, per il suo commercio di vini, la città più animata dei Monti Albani. Dalla parte opposta si scende in un burrone selvaggio, dove tombe misteriose e antichissime si nascondono nelle rupi; di qui si gode di una veduta davvero incantevole del famoso bosco di querce e della vetta di Monte Cavo; qui si trovano molte fontane, alle quali scendono le massaie a lavare la biancheria e dove si svolgono tutto il giorno scene assai varie e rumorose. L’acqua di quelle fontane era la più celebrata di tutto il Lazio, or sono ben più di mille anni, poiché nel magnifico burrone si trova la sorgente della Ferentina, intorno alla quale si riunivano i popoli latini nella gran festa di quella dea, dopo aver pellegrinato solennemente alla cima del monte Albano. La divina sorgente mormora ancora e zampilla attraverso i secoli e il sacro boschetto verdeggia eterno”. Per introdurre Grottaferrata ci serviamo della sensibilità di Valery: “L’abbazia dei monaci greci dell’ordine di San Nilo rimonta all’anno Mille e presenta l’aspetto di una fortezza del XV secolo. I monaci vi celebrano sempre l’ufficio secondo la loro liturgia e la consulta francese di Roma non li soppresse a causa del loro canto trasmesso per tradizione. Bessarione era stato il primo abate commendatario di Grottaferrata, spesso vi riunì alcuni dei suoi dotti e sfortunati compatrioti. La biblioteca del monastero ha numerosi manoscritti greci meglio conservati che al tempo in cui Francesco Barbaro, ambasciatore della repubblica di Venezia a Roma, li aveva trovati nella cantina accanto ai vasi di vino. Un bosco incantevole, un bel viale di olmi e di platani, con una graziosa fontana, rendono deliziosa questa solitudine”. Ad illustrare Frascati ci pensa il grande poeta tedesco Johan Wolfgang Goethe: “Il luogo è delizioso, il paese giace su un colle, o meglio su un monte, e al disegnatore si scoprono ad ogni passo i soggetti più splendidi. Il panorama è sconfinato: si vede in basso Roma e più lontano il mare, a destra i monti di Tivoli e via dicendo. In questa piacevole regione le case di campagna sono veramente fatte per il piacere e come i Romani antichi avevano qui le loro ville, così, da cent’anni e oltre, romani e ricchi amanti dello sfarzo hanno gettato nei punti più belli della zona, le radici di nuove dimore. Già da due giorni ci aggiriamo in questi luoghi e troviamo sempre qualcosa di nuovo e d’incantevole”. Seguono due monti: Monte Porzio Catone, di cui dice Montesquieu: “Il primo giugno 1729 sono stato a Monte Porzio, villaggio che appartiene al principe Borghese. Là era la casa di Marco Porzio Catone che discendeva da una famiglia originaria di Tuscolo. Nel villaggio c’è una chiesa molto bella di ottima architettura. Da là si vede tutta la campagna romana ad ovest e a settentrione, sino alla catena di montagne dove abitano i Sabini; si vede Tivoli e Palestrina, verso il pendio dei colli a settentrione si vede il monte Soratte e altri paesi”; e Montecompatri di cui ci parla Francesco Saverio Kambo: “Da Monte Porzio a Montecompatri la via è tutta ombrosa di castagneti. Montecompatri s’eleva assai in alto sulle ultime propaggini dei Colli Tuscolani e originò forse completamente dall’esodo dei tuscolani. In un luogo di beatitudine silente, non lontano da Montecompatri e assai più elevato, fra il verde dei castagni e dei vigneti, biancheggia il convento di San Silvestro. Il santuario è antichissimo: la leggenda racconta che San Silvestro papa qui si rifugiasse coi proseliti cristiani durante le persecuzioni imperiali”. E concludiamo con due rocche: la prima la affidiamo, pur fra tanti testimoni stranieri, a un italiano, Massimo D’Azeglio: “Una vista come l’avevo dal balcone della mia camera a Rocca di Papa e che tanto campo offrisse alla immaginazione, alle grandi memorie, al gusto artistico, e alla poesia, non l’ho mai incontrata in nessun luogo, e neppure che le si avvicinasse”. La seconda la lasciamo al pittore russo Maltzeff: “Il consiglio dei professori dell’Accademia di Belle Arti di Pietroburgo mi assegna il Prix de Rome consistente in un viaggio e soggiorno a Roma per 4 anni. Il primo gennaio 1914 risiedo a Roma dove resterò per l’intera mia vita. … A Rocca Priora dipingo per i Padri Pallottini sette quadri e due per la chiesa parrocchiale. Sono trent’anni che nella stagione estiva soggiorno a Rocca Priora che considero il mio paese natio”.
Il privilegio della villeggiatura nei Castelli Romani di papi, principi e cardinali nel settecento si estese nel corso del secolo successivo al generone romano: “E m’aricorderò sempre a Marino/ indove tutti l’anni annamio fora/ d’ottobre a villeggià co la signora,/ e ce stamio inzinente a Sammartino”. Così testimonia Giuseppe Gioachino Belli la sua esperienza di ottobrata che i romani usavano consumare fuori porta. Ma chi poteva permetterselo lasciava Roma ai primi caldi insopportabili dell’estate e si rifugiava sulle alture dei castelli Romani fino a ottobre. Le mete predilette erano Frascati, la città più vivace di tutte, ma anche Marino, Montecompatri, Rocca di Papa, Castel Gandolfo. Chi aveva una casa propria e chi andava in affitto. Chi cercava la frescura delle alture, chi i piaceri del lago e dei boschi, chi ancora balli e feste mascherate, concerti e spettacoli teatrali. Gli alberghi e le famiglie ospitali, o pensioni, che oggi chiamiamo bed and breakfast, proliferavano nei centri storici dei Castelli e contribuivano a sostenere l’economia di base delle comunità locali. In ognuno di questi paesi si formavano delle comitive di villeggianti che davano vita e colore allo stesso luogo che li accoglieva. I villeggianti tornavano poi nell’Urbe alle prime brume di ottobre. Da qui deriverebbe il detto romanesco: “So’ arrivati i frascatani!”, alludendo agli incipienti rigori della stagione. L’ottobrata tradizionale era però circoscritta alle famiglie di operai e di impiegati che non avevano la possibilità di praticare una lunga villeggiatura. Era un episodico incontro fra la città e la campagna, tra la gente che abitava a Roma e quella che abitava nei Castelli Romani, della durata di un giorno o al massimo di un fine settimana, che prevedeva la scampagnata ai vigneti già carichi d’uva matura, con pranzi all’aperto, o sotto i pergolati. Testimoni le stampe di Bartolomeo Pinelli, le Minenti, cioè le ragazze o le donne romane “eminenti” per sfoggio di costume o di bellezza rallegravano la comitiva, ballando il saltarello, o cantando canzoni popolari, accompagnati da chitarre, mandolini e tamburelli di giovanotti scapoli e ammogliati. Alla sera facevano ritorno a Roma, non prima di aver fatto un chiassoso attraversamento dei centri abitati di Albano e Marino per raggiungere l’Appia. Sulla Regina Viarum si poteva allora vedere una lunga fila di decine carrozze tutte infiocchettate per l’occasione dalle quali le Minenti si sbracciavano, esibendo fino all’ultimo i loro sgargianti vestiti, a volte tagliati e cuciti per l’occasione e cantando stornelli come questo: “Fior de ricotta, / me vojo divertì come ‘na matta,/ cantanno ritornelli for de porta!”. Alcuni dei gitanti erano ospiti di parenti e amici che li traducevano nelle loro vigne, altri meno fortunati si accomodavano sui freschi tavolati delle cantine dei centri storici, all’insegna del risparmio, con un pranzo più o meno frugale portato da casa. Con la merenna si consumava l’ultimo vino rimasto in cantina, prima della nuova vendemmia, insieme a qualche coppietta di carne di cavallo, alla saporita porchetta, e a qualche altro seducente e piccante companatico. Per lungo tempo la cantina, o fraschetta, o bettola, come meglio usano chiamarla gli abitanti dei Castelli, è stato il fulcro intorno al quale ha ruotato la commercializzazione spicciola e diretta del prodotto vitivinicolo locale, altrimenti condotto con i carretti a vino nelle osterie e sulle tavole dei romani. Nei Castelli la bettola è stata un’autentica istituzione economica e sociale e ancora oggi, sebbene un poco cambiate, è possibile visitarne ancora molte. Qui la parola bettola non ha nessun connotato dispregiativo, come accade in altre parti d’Italia, quasi fosse una taverna di basso rango. Qui il contadino trasforma in un periodo dell’anno la sua cantina, dove ha vinificato le uve, in un locale rustico atto alla vendita diretta del suo vino. All’interno un semplice tavolato accoglie i commensali e il vino è direttamente scavolato dalle botti o prelevato fresco dal grottino sottostante; all’esterno il segnale convenuto: una ramo d’alloro selvatico che richiama l’avventore, indicando l’apertura dell’improvvisato commercio e una bandiera di stoffa azzurra o rossa con le cifre scritte a gesso del prezzo praticato. L’avventore vi può acquistare solo vino sfuso e godere dell’accoglienza del vignaiolo. Se vuole mangiare qualcosa deve provvedere, portando da casa il fagotto, cioè l’involto contenente i generi commestibili, oppure acquistando nelle rivendite del posto carni salate, ricotta, formaggi piccanti, olive, ciambelle.
Nel 1856 venne inaugurata la prima linea ferroviaria dello Stato pontificio: la Roma – Frascati. Tuttavia occorrerà attendere il 1889 perché le nuove tecnologie e la volontà del nuovo Stato italiano rendessero le linee efficienti ed economicamente accessibili a tutti le corse fra Roma e i Castelli. Dal 1906, con la linea Roma – Grottaferrata – Frascati e poi Frascati – Marino – Genzano il tram, assai più versatile e capillare affianca e compete con la ferrovia. Dopo la prima guerra mondiale il processo di collegamento fra Roma e i Castelli è concluso e le masse domenicali assaltano i Castelli Romani. Il fenomeno viene simpaticamente descritto nel 1893 dal giornalista del Messaggero Luigi Palomba, che chiama treno Tropea l’ultima corsa per Roma dai Castelli, carico di famiglie operaie esauste della giornata di svago e di ubriachi che si tengono sul predellino esterno in cerca di aria fresca. Mentre all’inizio degli anni Venti del secolo scorso comincia a fare le sue prime timide apparizioni l’automobile, è il tram il vero mezzo di locomozione delle masse e senza questo tipo di trasporto una festa di massa, come la Sagra dell’Uva di Marino, non avrebbe avuto il successo che conosciamo. A questo punto la gita fuori porta e l’ottobrata romana diventano un fenomeno di massa con decine di migliaia di persone che si spostano ogni fine settimana da Roma ai Castelli. L’Opera Nazionale Dopolavoro, organizzazione del regime fascista, comprende al volo l’opportunità di organizzare il tempo libero delle masse e di indirizzarle al consumo di prodotti autarchici esaltati nelle feste popolari e tradizionali. La Sagra dell’Uva di Marino, iniziata nel 1925, assunse dal 1929 una fama nazionale e valicò i confini alla metà degli anni Trenta, reclamizzata da giornali tedeschi, statunitensi e sudamericani. Lo stesso Istituto LUCE produsse e diffuse con mezzi ancor più potenti dei quotidiani le immagini di una ottobrata nazionale con folle spensierate e contente partecipare a una vendemmiata pubblica ai limiti del parossismo, tale da richiamare alla mente altre italiche adunate, più o meno composte, più o meno massificanti. L’impressione suscitata dalla grande partecipazione di gente alla Sagra dell’Uva di Marino venne ben descritta dal giornalista Ettore Veo alla metà degli anni Venti: “E alla fine se ci tenete al colore, alla gaiezza diffusa, al movimento vero e proprio del popolo correte a Marino nel dì della Sagra dell’Uva: è una festa quanto mai simpatica e vivace, poiché racchiude in una tutte le ottobrate antiche e recenti. … La festa anno per anno ha acquistato maggior fascino e nuove attrattive ed è entrata , di subito, nell’ormai breve numero delle superstiti feste popolari della Capitale”.
Ultimo capitolo dei Castelli Romani è quello che è stato scritto nel corso dell’ultimo mezzo secolo scorso. A partire dagli anni Cinquanta i Castelli godevano nell’immaginario collettivo di una fama positiva: dall’aeroporto di Ciampino scendevano personalità politiche e attori italiani e stranieri che spesso preferivano alloggiare nei Castelli Romani, piuttosto che a Roma. De Gasperi abitava in un villino posto alla sommità del lago di Castel Gandolfo, Sofia Loren e Carlo Ponti dimoravano a Marino nella settecentesca villa Gabrielli, Moravia e poi Umberto Mastroianni, nella casina Colonna di Marino, Antony Quinn ad Ariccia, Gian Maria Volonté a Velletri, e poi Virna Lisi, Sylva Coscina, solo per citarne alcuni. Alla fine degli anni Sessanta i Castelli Romani si illudevano di essere la Beverly Hills di Hollywood – Cinecittà. Nel giro dei trenta anni successivi la fuga da Roma di chi poteva assicurarsi una seconda casa ai Castelli e poi di fasce sempre più ampie di persone che hanno trovato più economico l’acquisto ai Castelli anche della prima casa, hanno determinato un assottigliamento del territorio e delle risorse disponibili, uno stravolgimento del paesaggio, come non c’era mai stato in migliaia di anni, un radicale mutamento delle abitudini e dei costumi tradizionali, avvenuto questo sì un po’ ovunque, ma che già Pasolini preconizzava come generale processo di omologazione, riscontrandolo prima che altrove proprio nei Castelli Romani, di cui era frequentatore e attento conoscitore.
Ultimo fenomeno, quello della globalizzazione, fa sì che la gita fuori porta si faccia in aereo a Praga, o Londra e le vacanze anche fuori del continente. Resta è vero la rete di ristoranti, cantine e osterie tipiche che funzionano a pieno regime il sabato e la domenica, ma gli abitanti dei Castelli Romani, raddoppiati nel giro di trenta anni, non parlano quasi più il loro dialetto, spesso non conoscono i vicini di casa, snobbano le loro stesse feste tradizionali. Insomma si avviano a diventare un sobborgo della Capitale.