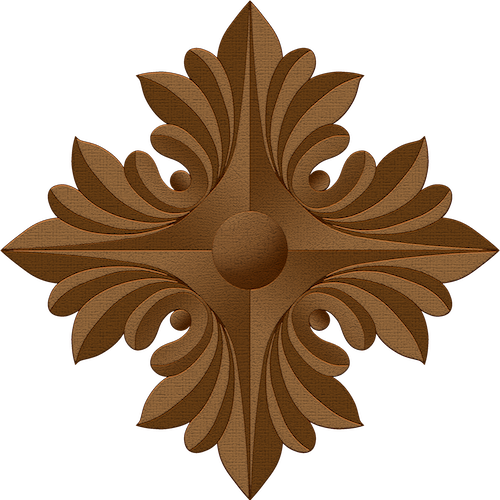di Marzia Mascelli e Gianluca Reddavide
di Marzia Mascelli e Gianluca Reddavide
Vi sono dei pensieri, o meglio delle immagini, della campagna romana che più immediatamente di altre vengono alla mente quando questo luogo vi è richiamato: si tratta delle riproduzioni che di essa fanno i vedutisti del Settecento e dell’Ottocento. Sono gli anni in cui i pittori celebrano con grande intensità tale luogo particolare del territorio laziale e riproducono sulla tela una realtà rurale che ben si presta ad essere fissata. Ciò che è rintracciabile come tratto comune all’interno di queste descrizioni pittoriche sta nel fatto che tutte le componenti paesaggistiche, siano esse architettoniche e archeologiche (le vestigia dell’acquedotto romano), umane (i contadini e i pastori), animali (le greggi a perdita d’occhio), sono ritratte in modo che esse comunichino una estrema staticità, che passa attraverso un apparente equilibrio ed una serenità di ogni elemento con se stesso e tra ciascun elemento.
Una sensazione di immobilità paragonabile a quella dei grandi quadri si può trarre anche dalle letture dei tanti diari, resoconti di viaggio e descrizioni letterarie che della campagna romana fanno studenti, intellettuali, viaggiatori e scrittori a partire dal XVIII secolo: la letteratura del Grand Tour restituisce l’idea di una campagna romana che sembra essere lontana da qualunque intrusione della storia, un territorio ed una umanità immobili e che possono attraversare il tempo senza che molto cambi. Trovano quello che cercano.
Si costruisce così l’immagine di un territorio che sembra escluso dalle vicende e dagli accadimenti presenti, invece, la confinante città e che resta immune dal suo sviluppo, sia esso culturale, architettonico o sociale.
Attraverso un’analisi fondata sui metodi storico-religiosi è forse possibile contribuire ad una visione ben diversa di questo territorio, che, sotto il punto di vista culturale, è luogo di dinamismo e labilità che scuotono l’immota apparenza attributagli da certa storiografia.
La campagna romana, o ciò che nella storia viene identificato con questo nome, è un territorio di confine, una frontiera fra la città di Roma e la realtà esterna. Tale posizione la carica di valenze e funzioni particolari nella costruzione dell’identità di ciò che essa separa.
La definizione, la plasmazione culturale dello spazio è un passo necessario e ineludibile nella costruzione di un’identità culturale ed è un’operazione ordinatrice che passa primariamente per l’opposizione tra interno ed esterno, tra dentro e fuori: da qui la centralità del confine e della frontiera. Per essa passano i rapporti o la negazione ddegli stessi, tra ciò che si decide debba stare da una parte o l’altra; in questo diventa altrettanto basilare che il confine sia flessibile, labile ed elastico.
Per evidenti ragioni storiche quest’area vasta e mobile acquisisce l’aggettivo qualificante e qualificativo di “romana”: si tratta di un elemento linguistico fondamentale in quanto chiarisce una tendenza centripeta, un movimento che porta ad annullare le differenze in nome di un’universalità politico-culturale che connota Roma. Essa, come fulcro che contagia e diluisce, in cui gli estranei finiscono per assomigliarsi, rende immediatamente impercettibili le diversità di tutto ciò che proviene dall’esterno e finisce al suo interno – che sia l’eterogenea moltidudine che da millenni forma la sua popolazione, o il sistema culturale e religioso, composto da singoli elementi di provenienza non romana ma assimilati a tal punto da divenire precipuamente “romani”.
In questo modo, come Roma è Urbe, e cioè la Città per eccellenza, e il popolo romano è il Popolo, allo stesso modo la campagna romana è la Campagna.
Tutto quanto oggi ci appare come un dato naturale, come qualcosa che da sempre è così; è in realtà un processo storico, frutto di scelte e di un orientamento deciso da Roma stessa in un momento preciso della propria vita.
Il primo passo è l’analisi di un’operazione concettuale che non ha eguali nella storia delle culture mondiali, e che caratterizzerà da allora in avanti la cultura occidentale: si tratta del passaggio fondamentale che rende la verità storica come l’unica accettata. Tutto ciò implica il non riconoscimento delle altre (quelle mitiche, filosofiche, spirituali), e l’assunzione dapprima dell’analistica pontificia, poi della storiografia vera e propria come sole depositarie della verità…che è “romana”, poiché tale è la storiografia e anche la storia che viene raccontata. In tale contesto la diversità si connota come tale soltanto perché ha a che fare con Roma e perché non è “romana”. La Campagna del periodo repubblicano ha un ruolo decisivo in quanto ciò che oggi appare come un mare magno di romanità era, invece, territorio incerto e fluido attraverso cui si definiva ciò che era romano e ciò che non lo era.
Per dare un’idea di questo processo culturale di definizione delle identità, vorremmo accennare a quattro casi esemplari, analizzati secondo una prospettiva storico-religiosa da Angelo Brelich e Dario Sabbatucci, alle cui opere rimandiamo per una lettura esaustiva sull’argomento.
Il primo caso è quello relativo all’istituto dei Feziali. Nella religione romana Iuppiter, divinità principale, aveva tra i tanti suoi attributi quello di essere garante dello status quo, cioè del pattuito: in questa veste gli era riservato il culto di Iuppiter Stator. Dunque quando scoppiava una guerra era come se si andasse proprio contro la stabilità voluta dalla stessa divinità. Era, quindi, necessario cautelarsi: a tale funzione erano posti i feziali che costituivano un collegio di 20 sacerdoti incaricati di compiere i riti prescritti per la guerra e la pace. Con la loro azione rituale giustificavano la guerra. Essi si inoltravano nel territorio nemico (che nei tempi più antichi della repubblica romana, quando i nemici erano i popoli confinanti all’interno del Lazio antico, coincideva con l’attuale campagna romana) e scagliavano una lancia pronunciando una formula rituale, nella quale la colpa della guerra era attribuita ai nemici, e dunque Roma, che rispondeva ad un’offesa, era protetta dall’ira di Iuppiter. Ecco che la campagna comincia a svelarsi come luogo di conflitto e azione rituale, di passaggio di eserciti, di guerre e paci.
Il secondo caso riguarda i rapporti tra Roma e Ardea, il terzo è relativo a quelli tra Roma e Veio, il quarto tra Roma e Praeneste: tre città appartenenti al Latium Vetus; tre città non romane che oggi sono isole romanizzate gravitanti nella zona di confine della campagna romana; tre città, infine, funzionali alla definizione della romanità, così come questa è stata plasmata e voluta dalla più classica e fondante opera di storiografia “Ab Urbe Condita ” di Tito Livio.
I rapporti tra Roma e Ardea vengono affrontati dal primo al nono capitolo del libro IV, in cui vengono redatti gli avvenimenti che vanno dal 445 al 443 a.C. Nei passi liviani gli Ardeati appaiono più come una connotazione che come una realtà, cioè essi servono a designare, a far emergere la situazione romana interna più che descrivere un pericolo esterno. Roma in questo momento è scossa da una crisi: i plebei sono in conflitto con i patrizi, poiché essi vogliono il conubium (matrimonio misto tra patrizi e plebei), al fine di accedere al consolato, finora riservato ai soli patrizi in quanto diritto di sangue (i consoli devono conoscere gli auspicia, che derivano dal sistema di diritti della propria gens). A Roma non regna, dunque, la concordia ma la discordia interna. Nel 445 Ardea minaccia di rompere l’alleanza con la Città. In tal modo tale conflitto interno tra patrizi e plebei viene proiettato all’esterno, ma rientra in essa quando questi ultimi minacciano di non andare alle armi contro gli Ardeati. La soluzione a questo ritorno della discordia all’interno di Roma sta in una rivoluzione, che è uno dei cardini della potenza romana: viene concesso il conubium e viene istituita la censura, che ha il compito di decidere sull’onorabilità di tutti i cittadini e, dunque, può stabilire se un plebeo possa auspicare oppure no (e quindi accedere al consolato). Finalmente adesso è possibile gettare all’esterno la discordia: il conflitto tra le clessi sociali romane viene spostato ad Ardea, dove la lotta scoppia tra patrizi e plebei ardeati.
È ora che si compie il capolavoro storiografico, lo spostamento definitivo tra ciò che è romano e ciò che non lo è: i patrizi richiedono l’aiuto dell’esercito romano, che pone d’assedio la città, mentre i plebei ardeati chiamano in loro soccorso i Volsci. Il conflitto interno ardeatino si trasforma in scontro tra Romani e Volsci, cioè tra “romanità” e “anti-romanità”, risultando così quello tra patrizi-plebei superato. Ardea ha, in tal modo, assolto alla sua funzione mediatrice in conseguenza alla funzione storica attribuitale dal destino fatale della grandezza romana.
I rapporti tra Roma e l’etrusca Veio si inseriscono nella medesima ricerca romana di concordia interna e di definizione del cosmo interno ed esterno. Tali rapporti si specificano nel ventiquattresimo capitolo del V libro, nel quale Livio assegna a Veio un modello in antitesi alla situazione romana: c’è la monarchia, che permette la concordia nella comunità. Il modello monarchico veiente è aborrito dai romani, ma Veio è resa desiderabile dalla concordia che regna al suo interno e che a Roma non è ancora guadagnata per sempre.
Nel 395 a.C. Veio viene vinta dai Romani e a Roma si fa largo l’idea di traferirsi in quella città.
Nel 390 a.C. si verifica il sacco di Roma operato dai Galli. Tale episodio è stato notevolmente ridimensionato da parte degli storici moderni (che lo definiscono come una scorreria non degna di enfasi), ma il fatto che esso assuma risalto nella narrazione liviana sembra seguire la funzione propria della storiografia romana: ecco che un elemento esterno (non romano) assolve alla funzione mediatrice. Si pensa di riedificare Roma (distrutta dai Galli) sulla concordia, trasferendo tutta la città a Veio. L’arrivo dei Galli giunge a proposito per proporre in maniera forte questa alternativa Veio-Roma che in realtà esprime un dissidio tutto romano, ancora una volta, tra patrizi e plebei. Era necessario sancire la concordia attraverso una scelta storica (andare o no a Veio) sulla base della precisa volontà del popolo romano, finalmente concorde.
I debiti culturali di Roma nei confronti di Veio sono noti. La comunanza e la vicinanza territoriale tra le due città era tale da non permettere differenze eclatanti. L’alternativa Veio-Roma è costruita da Livio come ipostasi tra concordia e discordia, all’interno di un complesso culturale che definisce l’altro rispetto a sé sulla base di confini e frontiere che sono soltanto interni.
Veniamo ora ai rapporti tra Roma e Praeneste: questi si definiscono invece nel ventottesimo e ventinovesimo capitolo del VI libro di “Ab Urbe Condita“. Tale incontro ha origine da un’invenzione dello storiografo, confutata dagli storici moderni, secondo la quale i Prenestini combatterono e persero contro Roma una battaglia in un luogo topico per la storia romana, l’Allia, che fu già teatro della rovinosa sconfitta inflitta a Roma dai Galli. L’invenzione sta nel fatto che né l’Allia, né la data riportata da Livio, rispettano la verità degli avvenimenti. Perché Livio scelse di alterare i fatti e inventò data e luogo della battaglia? La risposta sta, forse, negli stessi passi liviani, cioè nella contrapposizione, rispetto alla battaglia, dell’atteggiamento romano da una parte, e prenestino dall’altra. I Prenestini hanno speranza (spes) nella fortuna loci; d’altronde Praeneste era la sede del tempio di Fortuna Primigenia, divinità principale della città, e ad essa, ovviamente, ci si abbandona con speranza (spes). Il legame nel culto tra Fortuna e Spes è accertato: nel santuario prenestino di Fortuna vi era anche il culto di Spes.
I Romani, invece, hanno fiducia nel proprio destino storico. La fiducia è legata alla sfera della divinità principale dei romani, Iuppiter.
Si ha l’impressione che Livio voglia illustrare un contrasto di atteggiamenti religiosi tra la città di Fortuna e quella di Iuppiter. Tale impressione sembrerebbe confortata dalla tradizionale polemica tra Romani e Prenestini, questi ultimi sempre accusati dai primi di iattanza. Eppure il culto di Fortuna era stato accolto a Roma, anche se spogliato di alcuni suoi tratti specifici – l’oracolo e il culto di Iuppiter puer -; allo stesso modo a Praeneste era presente il culto di Iuppiter. Tutto ciò fa pensare che tale contrapposizione religiosa non fosse poi così netta se non nelle intenzioni storiografiche.
L’analisi dei miti di fondazione e delle loro varianti, quella dei culti, rende tale opposizione molto debole. Tutto fa pensare che Roma abbia voluto differenziarsi e contrapporsi a Praeneste inquadrandola nel proprio cosmo: l’opposizione di Praeneste appare agli occhi romani come un elemento destabilizzante del cosmo che Roma stava realizzando. In questo senso connotare Praeneste come affidata ad un elemento culturale (spes e Fortuna) in netta opposizione a quello romano (fiducia e Iuppiter), avvalorava l’idea che tutto ciò che era contario all’ordine romano fosse di per sé apportatore di caos. In Livio, dunque, Praeneste è il nemico esemplare in grado di far risaltare la virtus romana: la contrapposizione si fonda su un contrasto di categorie funzionale alla definizione di verità storica che, come accennato, deve essere romana.
Abbiamo scelto di percorrere questa strada per tentare di sottrarre al dato naturale ciò che in antico era zona di frontiera. Una frontiera non solo territoriale tra città-stato, ma ideale suscettibile di interventi e plasmazioni culturali che contribuivano alla edificazione e alla distruzione di limiti tutti interni alla città di Roma e all’idea che di sé la stessa ha voluto costruire e imporre. Roma, come detto, ha allargato il suo pomerio definendo differenze là dove non c’erano per poi distruggerle o assorbirle. La campagna era veicolo di trasformazioni interne ed esterne.
Oggi il pomerio romano è rappresentato dall’anello stradale che ridefinisce confini e valica vecchie frontiere. L’inurbazione continua a operare anche culturalmente l’annullamento o la creazione delle differenze tra ciò che è Roma e ciò che non lo è. La campagna è divenuta territorio da preservare dalle ingerenze di nuovi Feziali privi di giustificazione rituale.