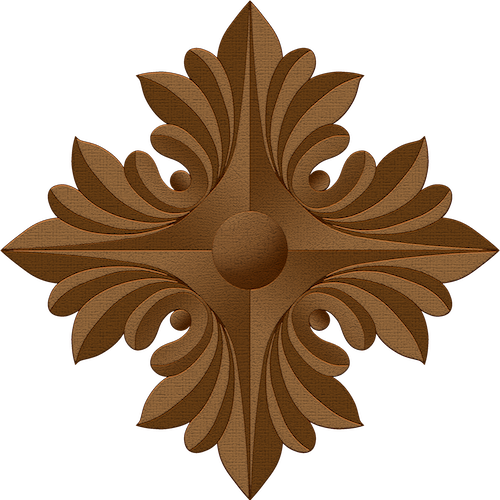di Francesca Accurso
di Francesca Accurso
Il territorio riveste per l’archeologo un interesse particolare; spesso la sua visione di “terra”, come luogo di raccolta d’informazioni culturali, si scontra con l’immagine materialista di alcuni che imperturbabili guardano il terreno, il territorio, lo spazio, in termini esclusivamente economici: come luogo per le attività agricole, rifornimento di acque, per l’acquisizione di risorse naturali e più spesso come zona di edificazione indiscriminata.
Il primo “sguardo” che l’archeologo dà alla terra è superficiale, ma questa delicatezza è di prioritaria importanza. Nelle ricognizioni sistematiche, nello scavalcare le dolci ondulazioni dei terreni solcati da fossati e marane, nell’attraversare i vasti tavolati tufacei così caratteristici della campagna romana, l’archeologo riesce fisicamente a misurare lo spazio e a riconoscere la ricchezza di indicatori archeologici e naturalistici; perché in questo modo è possibile sostenere che la concentrazione di materiali ceramici, disposta “sopra” la superficie del terreno, sia un segnacolo della presenza di strutture antiche “sotto” terra.
Alla fine degli anni sessanta un’urbanizzazione pressoché indiscriminata e disuniforme ha sconvolto rapidamente il suburbio di Roma ed ha reso impossibile guardare al paesaggio come ad un organismo unitario. Per millenni questo territorio, grazie alla presenza del nodo fluviale Tevere-Aniene e del “complesso dei colli Albani”, ha permesso la frequentazione umana ed il suo sviluppo in forme organizzate. Ma è pur vero che non esiste un paesaggio immutato nel tempo, che è impossibile che i lenti processi erosivi e i riempimenti colluviali naturali o i dinamici svolgimenti storici non trasformino irrimediabilmente il quadro naturale.
D’altro canto però è proprio l’impressionante e secolare suggestione paesaggistica della campagna romana, e in particolare del settore Sud-Est di Roma, compreso tra la Via Ardeatina e la Via Latina, che rende ostili di fronte a certe realizzazioni moderne che deturpano il territorio, il cosiddetto ager arcifinius degli antichi, “quello che non contiene nessuna misurazione”, dislocato come pelle di leopardo nella zona a ridosso della città di Roma e nell’area prossima ai centri abitati dei Colli Albani.
Questo modo, a tratti romantico, di vedere la campagna romana non esclude che, quando uno sviluppo edilizio è meno selvaggio e viene programmato sotto l’egida e il controllo della soprintendenza archeologica, il prodotto dell’azione dello scavare – di incidere artificialmente il terreno tanto da sollevarne gli “strati” – non sia da apprezzare. E’ proprio sotto questi buoni auspici che si muove l’intervento dell’archeologo, nel tentativo di aggiungere piccole tessellae storico-topografiche al più grande mosaico.
Nel corso di questi anni l’aumento d’indagini, e quindi di “agenti”, sul vasto comprensorio che qui genericamente denominiamo Osteria del Curato, ha mostrato come l’area sia stata frequentata intensamente. Questa frequentazione, risalente probabilmente al III millennio a. C., ha permesso che si riconsiderassero alcuni aspetti del modo di occupazione del territorio. L’utilizzazione anche del tavolato tuscolano in fasi così antiche sottolinea la complessa articolazione di piccoli gruppi umani lungo particolari punti di transito, che si possono definire commerciali. L’antica via di percorrenza, quella che è divenuta in tempi storici la Via Latina, probabilmente veniva usata come camminamento di transumanza, in quanto percorreva il versante dei Lepini, Musoni ed Aurunci, fino a raggiungere con il passo dell’Algido la lunga e fertile valle Latina (Sacco-Liri).
Molto più sistematiche sono le evidenze sull’area nel corso del XI-X sec. a.C.; un insediamento e distinta area sepolcrale dell’ultima fase del bronzo-inizi ferro sono stati riconosciuti su Via Lucrezia Romana. Ed è in questo periodo che diventa più visibile un’organizzazione territoriale. Si riconosce appunto la presenza di aree specifiche destinate agli abitati e alle sepolture.
È opinione sostenuta da molti studiosi che nel corso dell’età del ferro, con il processo di dislocazione, si faccia più forte l’idea stessa di confine, realizzato grazie alla presenza di barriere naturali come piccoli corsi d’acqua, oppure costituito in modo artificiale, attraverso muraglioni di difesa o l’imbrigliamento di fossati con blocchi di pietre allettati a secco. Inoltre si ritiene che la possibilità di scegliere particolari aree sia da collegare all’emergere di un’organizzazione sociale caratterizzata da gruppi di discendenza o lignaggi, ad esigenze di possesso, controllo e sfruttamento delle risorse territoriali.
Ma questo sarà un processo lungo e articolato secondo modi non sempre lineari che si realizzerà solo in età storica, quando sarà la città-stato gentilizia di Roma ad esercitare, intorno al VI sec. a.C., forme di controllo territoriale. Questo è un passaggio “cruciale”, anche perché molto difficile da individuare in campo archeologico.
Infatti lo sviluppo di comunità denominate “albensi”, durante la fase che gli archeologi chiamano Laziale, è quasi sempre riferibile al formarsi delle protocittà di Roma e di Albalonga. Ed è proprio a loro che si rivolge l’archeologo usando questi termini. In che rapporto sia la nostra unità territoriale con questi due colli è difficile da stabilire. Mancano informazioni archeologiche degli anni di passaggio tra IX e VI sec. a.C., momento che porta a compimento quella delicata serie di trasformazioni sociali e “politiche”. A livello archeologico, e quindi anche visivo, sono le cosiddette “tombe principesche”, accanto ad altri segnali di ricchezza materiale – oggetti in bronzo di raffinata fattura – dislocate sul territorio del basso corso del Tevere, che annunciano un’affermazione della gens sul territorio. Nei medesimi sepolcreti, come nel caso di Acqua Acetosa Laurentina, alcune tombe principesche, ovvero particolari strutture funerarie denominate “a camera” (in cui viene “sacrificata” un’enorme quantità di suppellettili ceramiche e metalliche) coesistono a tombe più modeste. Questa ostentazione è interpretabile come un segnale del principio di prevalenza, nel gruppo, del più ricco. Se nella comunità si modellano figure sociali economicamente emergenti in grado di difendere l’accesso differenziato delle risorse, in ugual misura è possibile che le stesse provvedano al benessere della società considerata nel suo insieme. Nonostante la mancanza di un controllo centralizzato della forza, che è prerogativa di un modello politico statalizzato, l’élite gentilizia fu capace di garantire la propria condizione di privilegio e aumentare le proprie ricchezze. Proprio l’esistenza di un complesso di vincoli sacri che autorizzano l’esercizio del potere può essere visto come la chiave di volta della coesione di gruppi sociali organizzati; sicuramente più efficace ed alternativa del controllo poliziesco, ed in grado, probabilmente, di creare una struttura nella quale l’élite sia stata l’interprete di determinati modelli culturali, attribuibili alla stessa interazione all’interno del gruppo sociale. E quest’azione direttiva ci piace pensarla come cresciuta sulla solidità di una base sociale non coartata ma “concupita”.
Questo è riferibile all’intero ambito dell’area laziale. Nel caso della nostra ipotizzata comunità di pianura, essa è probabile solo ritrovarla inserita nei possibili pagi, i gruppi rurali della campagna romana. Siamo però già arrivati al VI sec. a.C., epoca in cui Albalonga non è più un polo attivo, non più sede dell’arcaica festività, il Latiar , in onore di Giove; anzi lo stesso Mons Albanus viene visto come confine del territorio dell’aggressiva città di Roma. Quella Roma che, da primitiva sede emporica, grazie alla sua caratteristica di luogo di compenetrazione multietnica, è divenuta ormai una città vera e propria, avente le sue espressioni culturali (una unica lingua che è il latino), religiose (il culto di Giove sul colle Capitolino) e politiche, in seguito alla sua affermazione sul territorio circostante.
La Roma inaugurata da Romolo lascia il posto ad una Roma riformata: la tendenza ad unire e riformare si esprime bene nelle parole sintetiche di Carmine Ampolo, che così descrive lo scopo della riforma centuriata del re Servio Tullio: aveva la “duplice funzione di popolo in armi e di esercito che prende decisioni politiche”. La centuria è “non solo un’unità militare e di voto, ma è anche un’unità di misura della terra, o meglio, la designazione d’appezzamenti quadrati di terreno”. Così, con la distribuzione d’appezzamenti privati di terreno anche a cittadini non facenti parte dei gruppi elitari, dapprima nell’area urbana ed in seguito anche nel suburbio, si affermano e si integrano alla piccola proprietà contadina – che sopravvive grazie a questa distribuzione della terra – figure sociali alternative in principio marginali come gli stranieri o gruppi di artigiani. La prima cinta muraria delimita la città di Roma in base alla residenza; una seconda cintura si costituisce con la creazione di tribù rustiche (forse in numero di 15, più le 4 urbane), che abbracciavano probabilmente i preesistenti pagi extraurbani. Ed è possibile che una tribù Lemonia fosse localizzata proprio nella zona intorno all’Osteria del Curato; certo è, però, che questo territorio extraurbano sia ricostruibile in base agli indizi archeologici rappresentati dai santuari: diversamente da quello primigenio ed emporico di Portunus, identificato nel Foro Boario, e della progressiva nascita di altri con destinazione politico-religiosa, l’edificazione di questi è anteriore alla presa di Veio (396 a. C.) ed è in relazione ai confini del pomerio territoriale di Roma che in età arcaica si riconosceva al V miglio.
Lungo Via del Quadraro cade attualmente il confine tra il IX e X municipio di Roma, coincidendo con una località riconosciuta nell’antichità come teatro di episodi particolari, come quello del vittorioso patrizio romano Coriolano che, dopo la cacciata dei re di Roma (509 a C.), fu protagonista di superbe vittorie contro i Volsci, genti del Nord-Est venuti a occupare il territorio tra l’Appennino, la fascia tiberina e quella costiera laziale. Accusato di sovvertire le leggi della Repubblica durante le feroci lotte che dividevano i patrizi e i plebei, Coriolano fuggì da Roma a Veio, dove riunì un esercito per poi muoversi alla conquista della sua città. Con esso si accampò sul confine dello stato di Roma e di Albalonga. I romani per patteggiare la pace inviarono la madre e la moglie di Coriolano, il quale, vedendole, turbato riportò i Volsci ad Anzio. Le donne su quel luogo vollero innalzare un santuario dedicato alla dea Fortuna Muliebre, nel quale era possibile che venisse celebrata una solenne lustratio – una sorta di processione purificatrice – dei confini. L’identificazione di un complesso d’edifici proprio a Nord del cavalcavia di Via del Quadraro, recentemente individuato dall’archeologo Roberto Egidi, con l’antico tempio non è confermato. Ma una serie di strutture ipogee e a cielo aperto, ad uso funerario e abitativo, si ritrova lungo i miliari IV e V. Accanto a queste strutture, che per la loro stratificazione testimoniano la continuità di vita del luogo (dalla fase repubblicana alla fine del III sec. d.C. C.), è stata riportata alla luce una sepoltura orientalizzante (VII sec. a.C.).
Anche al V miglio della Via Campana sorgeva un antico santuario: quello della Dea Dia, in un luogo (l’odierna stazione della Magliana) che riuniva una confraternita religiosa, i fratres arvales. Questa “famiglia spirituale” invocava, attraverso un rituale complesso, i “Lari” per la protezione dei confini territoriali (di Roma). Diversamente, in qualità di “lares viales”, ovvero dove le strade s’incontrano, gli arvali invocavano questi genii, come protettori dei pagi. Proprio in connessione dei “crocicchi” si disponevano i villaggi rurali, costituiti da fattorie e case di campagna. Questi villaggi erano di modeste dimensioni (circa 1 ettaro), ma presentavano, già in età alto-medio repubblicana, dei veri e propri fenomeni d’aggregazione, i vici. Con questa cerimonia di purificazione è vero che si cercava di allontanare i “fantasmi dei demoni maligni” che circolavano nei vici e suscitare la protezione di demoni benigni; ma attraverso un reticolo di aspetti economici
(i momenti di mercato), politici e sacrali veniva anche espresso un ancoraggio territoriale.
Proprio per rispettare la memoria di un territorio o di un locus impregnato di sacralità si ripete un rituale: perché l’irruzione del sacro va tenuta sotto controllo, va trasformata e addomesticata e inserita in un contesto culturalmente accettabile. Tutto questo è sintomatico di quella volontà e pensiero tipicamente umano di trasformare il mondo naturale in mondo culturale.
Con il concetto di limite sacro e inviolabile e con la sua visibilità sul territorio – grazie alla costruzione sia di grandi santuari visti come centri di riunione religiosa e politica, oltre che di altri più piccoli intesi come “punti di raccolta”- per i pagi comincia ad essere più sensibile la dialettica città-pagi. Se il pagus Lemonius (o altri villaggi rurali distribuiti nella campagna romana), ricordato da Festo e ancora vitale in età storica, si fosse trasformato o assimilato ad un’unità amministrativa in funzione delle esigenze della città di Roma non è molto importante. Sebbene la comunità civica romana rafforzava la sua identità attraverso istituti già formalizzati (codificati nelle XII tavole), tendenze più dinamiche periferiche costituirono il necessario complemento di un sistema di potere centrale, unitario ma intenzionato a non escludere la possibilità d’arricchimenti culturali e proposte politiche.
Importante è il panorama insediativo di questo territorio periferico che trova riscontro a livello archeologico. Se fino al III e IV miglio è visibile, soprattutto nell’area del Parco delle tombe latine, un’ininterrotta sequenza in cui edifici funerari monumentali e complessi abitativi “…si susseguono senza soluzione di continuità e nette cesure tra il mondo dei vivi e quello dei morti…”, dal V-VI miglio, arrivando fino alle falde dei Colli Albani, si riscontra a livello archeologico un grande sviluppo agricolo di questo territorio, solcato dai percorsi irradiatisi da Roma ed ormai storicizzati, come la Via Latina, Labicana, Appia e Prenestina. In questo caso le testimonianze archeologiche sono costituite dalle numerose villae rusticae, collegate tra loro da un reticolo di diverticoli, che tra il II e I a.C. (grazie anche alle fonti d’approvvigionamento idrico garantite dagli acquedotti romani) si svolgono con una successione d’ambienti su vasti appezzamenti. Un esempio per tutti, visto che come dice il Lanciani queste ville “sono modellate su un tipo uniforme, a grandi scaglioni o terrazze, sorrette da muraglioni rettilinei rinfiancati da speroni, ed ornati di nicchie”, la Villa dei Settebassi, tra il V e VI miglio della Via Latina, una struttura costituita da tre corpi di fabbrica organizzati intorno ad un ippodromo-giardino, più un quarto corpo distaccato. Completa il quadro d’insieme una grande cisterna, posta alla fine di un piccolo acquedotto, che si allacciava all’ Anio novus.
Questo fenomeno d’insediamento rustico sarà più evidente in età imperiale e tardo antica, quando la separazione tra il mondo della campagna e quello della città sarà molto forte, probabilmente dovuto all’innalzamento a scopo difensivo delle mura Aureliane. Non si costruisce più nell’agro: le domus, con annessa la pars rustica, tardo antiche, difficilmente sono costruite ex-novo; anzi risultano quasi sempre definite nell’assetto topografico precedente con notevoli modificazioni interne.
Il funzionamento di una villa rurale o urbana presuppone una gerarchia di comando: la villa è un sistema economico-politico che ha un fine produttivo. L’agricoltura nella villa, come dice Andrea Carandini, è un reticolo di “…orti, frutteti, vigneti, oliveti, campi frumentari, prati e boschi…” ed è molto spesso inserita in un paesaggio che la distingue ulteriormente. E’ metodologicamente corretto studiare la villa attraverso sia i suoi rapporti interni sia quelli con il territorio circostante. La Villa dei Settebassi è inserita sul luogo occupato dal pagus Lemonius che, si è visto, faceva parte del sistema dei pagi periurbani. Probabilmente per il fatto di essere stato accorpato con la Villa dei Quintili sull’Appia in un unico fundus – appartenente prima all’imperatore Comodo ed in seguito a Costantino – è possibile parlarne come di “comune rustico”, nel quale si sia continuato a beneficiare di un certo grado di autonomia sia economica che politica.
La conduzione interna di un’azienda agricola richiama al rapporto tra il dominus e i professionisti della terra, schiavi o coloni che siano. Il crescente bisogno di forza-lavoro in campo agricolo va di pari passo con una condizione di vita più umana dello schiavo. La tendenza alla “riproduzione in villa” dello schiavo avvantaggia sia la produzione agricola con l’avviamento professionale nell’azienda, sia il legame dello schiavo con la proprietà. Per lo schiavo tardoantico il dominus è motivo di sicurezza, la stessa liberazione è vista con preoccupazione. La paura di peggiorare la propria condizione con l’allontanamento dal fondo è uno degli aspetti della “struttura chiusa” dal punto di vista sociale della villa.
Forse collegata alla pars rustica della Villa dei Settebassi è una vasta area di sepolture localizzata a Sud a ridosso del VI miglio della Via Latina. La maggior parte di queste necropoli presenta una sostanziale omogeneità nel costume funerario: sono ricavate incidendo il terreno fino ad incontrare il piano sterile tufaceo. Queste tombe generalmente si trovano delimitate da recinti murari. Le singole fosse si dispongono secondo un orientamento più o meno costante. Tra i tipi di sepoltura risulta predominante l’inumazione rispetto alla incinerazione. Molte di queste fosse venivano foderate e coperte; la copertura che genericamente si ritrova in questi sepolcreti è detta “alla cappuccina, una tecnica che consente di disporre delle tegole per formare una sorta di tetto. Era consuetudine in queste tombe deporre accanto alla salma un oggetto come corredo, oppure correlato ad un’offerta della persona defunta, come la moneta o la lucerna. Oggetti che aiutano l’archeologo a definirne l’arco cronologico. Gli esemplari d’uso domestico, come boccalini e pentole, nonché le stesse tegole di copertura, sono utili elementi per l’interpretazione delle fasi evolutive delle necropoli. La datazione proposta è circoscritta tra il I ed il III sec. d. C. Proprio per la vicinanza della necropoli alla grande Villa dei Sette Bassi e per i risultati dello studio antropologico fatto sugli individui, è stato possibile ipotizzare la frequentazione di quest’area da individui appartenenti ad un ceto modesto (forse contadini, o schiavi) legati a forme di sfruttamento agricolo dei terreni circostanti la villa.
Le interpretazioni date sulla base degli indicatori archeologici e le testimonianze letterarie antiche permettono di seguire un percorso che porterà ad un progressivo abbandono delle ville cosiddette “schiavistiche”. I grandi cambiamenti che si succedono con la crisi dell’impero romano d’Occidente investono le componenti essenziali della società. È naturale che anche il settore chiave dell’economia antica, la produzione agricola, ne risulti toccato. Il fiscalismo accresciuto dalle riforme dioclezianee vincola la popolazione agricola alla terra. In seguito anche le invasioni germaniche ridefiniscono lo stesso paesaggio. L’abbandono delle terre meno produttive, che si trasformano in macchie e terreni incolti, perdendo così il loro connotato tipico “dell’ordine romano” centuriato, e la riscoperta economica degli spazi aperti – pascoli e aree marginali come paludi e foreste – che cominciano ad esser presi in considerazione (anche a livello letterario e agrimensorio), sono probabilmente il segno che le “gentes externae” portano nell’economia romana. La caccia, l’allevamento allo stato brado e la rilevanza economica di prodotti silvestri come il miele sono il risultato di quel “sistema agro-silvo pastorale sul quale [il modo di vita dei germani] si fondava” (A.Giardina). Non solo: i territori diversi e la loro rilevanza economica sono fatti oggetto di regolamentazioni da parte dei “regimi” barbarici. Figure sociali itineranti come pastori, briganti e in seguito monaci erranti appaiono con la loro aurea di “irregolari” nel periodo tardoantico e successivamente nell’alto medioevo. Ma l’aperta campagna conserva i suoi regolari “spazi chiusi”. Esempi di ulteriori riconversioni si hanno nella tenuta di Passo Lombardo (Tor Vergata) dove in occasione di scavi recentissimi si è individuata una villa romana con una pars rustica attrezzata per un’attività artigianale (vinaria) le cui ultime testimonianze risalgono al VI sec. d.C.
L’archeologo si ferma qui. Ha cercato di raccontare millenni di vita in uno spazio brevissimo, forse ha osato un tantino e chiede venia. Ma si è accorto che se i segni sul terreno si ritrovano nella Campagna Romana così distribuiti, come nel caso del nostro comprensorio, si possono azzardare distintive considerazioni sul suo utilizzo. Se si tenta, come si è cercato di fare sin dall’inizio, di intendere la “sacralità” come un effetto e tradurla “con l’idea di intoccabilità o inviolabilità – di presupposti, di principi, valori, ma anche di luoghi (i paesaggi naturali), oggetti e persone” si è disposti a identificare tali segni come dei luoghi fisici.
Così la fisicità di questi “luoghi” si determina per il fatto di promuovere delle attività umane: se esisteva una concentrazione di comportamenti religiosi e laici in passato, nei vari centri del territorio suburbano, è perché esisteva la volontà da parte di un gruppo umano di contrastare con la propria opera di misurazione la fluidità del tempo e l’omogeneità dello spazio.
Questa sintesi spazio-temporale, concepita in modi e in tempi diversi, ritorna in ogni tipo di centro, in virtù della capacità d’ogni forma di organizzazione sociale e culturale di operare sul territorio circostante.
Ed è proprio questa funzione di “ancoraggio territoriale”, che è stata così rilevante in passato, tanto da rivestirla di sacralità, che si deve far propria nell’immediato futuro.