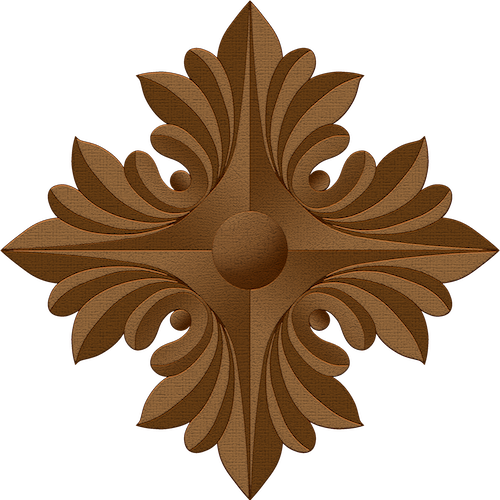di Diego Angeloni
Fin dall’antichità, la necessità di disporre di acqua potabile in quantità sufficiente ai bisogni giornalieri di una città fu un problema particolarmente sentito.
A tal fine già le civiltà mesopotamiche avevano sviluppato sistemi per il trasporto sotterraneo delle risorse idriche e anche le popolazioni elleniche avevano perfezionato la tecnica di canalizzazione e forzatura del cammino delle acque. Gli acquedotti costruiti dai romani, però, non servirono solo per soddisfare il fabbisogno idrico, ma costituirono anche uno strumento di potere e furono la leva urbanistica, architettonica e sociale della società romana; possono essere, quindi, considerati l’assunto del particolare clima culturale dell’epoca. I romani perfezionarono, dunque, una tecnica già in uso prima di loro e la raffinarono così da portare, lentamente e senza bruschi dislivelli, l’acqua a Roma.
La costruzione di arcate monumentali che si stagliavano su tutto il territorio a sud di Roma, l’innalzamento di grandi ponti a guado di fiumi e strade, nonché tutte le opere di servizio come piscine limarie, castelletti, mostre e semplici fontane consentirono che un fiume d’acqua potabile, incanalato alla sorgente, arrivasse direttamente nel centro cittadino ad alimentare la grandezza della Roma imperiale. Christian Norberg-Schulz, nel libro Genius Loci, afferma: “Anche l’acqua può essere “edificata”, dandole la definizione precisa di elemento partecipe di un paesaggio culturale,…”; così i romani, “edificarono” l’acqua rendendola una componente fondamentale del loro stile di vita.
Ma il loro rapporto con l’acqua non fu sempre di superiorità, essa venne anche temuta e contrastata. Infatti, sebbene essi riuscirono nell’impresa di portare acqua sorgiva in città, prelevandola da fonti distanti decine di chilometri, non riuscirono a risolvere completamente un altro problema legato all’acqua e cioè le inondazioni del Tevere e dei numerosi fiumi secondari che scorrevano nel territorio dell’Urbe. Così, mentre per questi ultimi vennero realizzate opere di contenimento risolutive, per il fiume principale non si riuscì, per molto tempo, a frenare le inondazioni che andavano ad allagare non solo il centro cittadino ma che si spingevano nella gran parte della campagna circostante. Anche gli stessi acquedotti, non portarono solo ricchezza, infatti, seppur per circostanze non controllabili, causarono effetti nefasti, come la malaria e la peste, sviluppatesi nella campagna in seguito all’interruzione delle arcate avvenuta nel VI secolo d.C. Vitige, re dei Goti, costrinse Roma alla resa “assetandola”; sfruttando, cioè, una postazione strategica creata dal percorso “naturale” di due acquedotti: il Claudio e il Marcio. Questi ultimi, nello spazio di trecento metri, si incrociavano per due volte, creando un invaso trapezoidale già parzialmente fortificato. Bastò tamponare le alte arcate con pietre e terra per creare una fortezza inespugnabile capace di accogliere l’esercito barbaro. Da considerare, inoltre, che in questo tratto passavano la via Latina e la via Appia, due principali accessi alla città, risultanti, in tal modo, facilmente controllabili. Tale area, denominata “campo barbarico”, costituì il punto nevralgico del fallimento della strategia difensiva romana e si rivelò, anche successivamente, uno snodo destinato a cambiare le sorti di Roma.
Questo episodio è estremamente importante per comprendere ciò che si verificò, in seguito, nel territorio circostante. L’acqua infatti, cominciò a fuoriuscire senza poter essere domata e andò ad accumularsi in larghi strati della campagna favorendo la formazione di acquitrini e di zone paludose, tanto che, lo stesso campus barbaricus dovette essere evacuato a causa delle malattie che cominciarono a decimare i soldati. A partire da questo momento, la campagna romana perse la patina di splendore che l’aveva resa un’estensione del centro cittadino, fino a diventare un luogo deserto e malarico.
Ancora nel XIII secolo, in questa stessa zona, la presenza degli acquedotti costituì la base di una serie di avvenimenti infausti per Roma. Proprio uno dei punti di intersezione tra l’acquedotto Claudio e il Marcio costituì le fondamenta di una torre difensiva che portò al potenziamento di tutto il campo barbarico, tanto da renderlo l’accampamento ideale per gli eserciti nemici e per le loro mire espansionistiche su Roma. Per la costruzione della torre, chiamata dal XVII secolo Tor Fiscale, si predisposero delle solide basi sfruttando l’intersezione perpendicolare dei due acquedotti, le cui arcate, usate come punti di appoggio, permisero alla torre di svettare sul territorio circostante e di divenire un punto di controllo privilegiato sulla campagna.
Malgrado ciò, per tutto il periodo di massimo splendore, durante gli otto secoli dell’età repubblicana e imperiale, Roma non fu eguagliata da nessun’altra potenza per quel che riguarda l’approvvigionamento idrico. Grazie agli undici acquedotti che arrivavano in città, poterono essere costruiti grandi complessi termali sparsi tra il centro cittadino e le zone limitrofe; vennero realizzati laghi artificiali circondati da terrazze, portici e peristili scenografici per adornare i grandiosi giardini imperiali; e poi, grazie all’enorme disponibilità d’acqua, si costruirono ninfei arricchiti da statue e stucchi decorativi e ancora stabilimenti balneari e un numero incalcolabile di vasche e fontane disseminate lungo le strade e nelle piazze, per soddisfare le esigenze quotidiane della popolazione che non poteva permettersi l’acqua all’interno delle case; vennero inoltre ideate le naumachie, la prima delle quali, finanziata da Cesare, si tenne nel Campo Marzio. In seguito Augusto e Domiziano fecero scavare dei bacini dedicati alle battaglie navali; quello fatto costruire da Augusto era alimentato da un acquedotto appositamente edificato che prelevava l’acqua dal Lago di Martignano.
L’abbondanza di acqua era tale, che permise nella campagna lo sviluppo di un susseguirsi di palazzi, residenze padronali, giardini pensili, terme private e splendide residenze patrizie, come la Villa delle Vignacce, la Villa dei Sette Bassi, il Triopio di Erode Attico e la Villa dei Quintili; ma, allo stesso tempo, anche di semplici residenze legate all’imprenditoria agricola.
La zona sud-orientale di Roma, quella corrispondente all’attuale Parco degli Acquedotti, in epoca imperiale doveva essere costellata da un fittissimo tessuto edilizio, reso possibile dall’attraversamento dell’area da parte di importanti vie di comunicazione, e dei principali acquedotti che facilitavano il rifornimento idrico. Coloro che potevano permetterselo costruivano dei veri e propri acquedotti secondari, rami distaccati, che arrivavano nelle loro ville ad alimentare fontane, ma anche orti e allevamenti ittici.
L’immagine della campagna non era, dunque, come potremmo immaginare, costituita soltanto da un succedersi di campi, vigneti, frutteti e di zone lasciate a pascolo; la componente agraria certo non mancava, ma ad essa si affiancavano emergenze architettoniche che la rendevano un susseguirsi di episodi estremamente vari, tanto che la grandezza di Roma non si poteva ritenere circoscritta alle sue mura, ma proseguiva fino alla campagna stessa. La maestosità retorica che percepiamo oggi non era certo avvertita nella Roma antica, gli acquedotti non erano infatti isolati in un paesaggio desolato e deserto; le coltivazioni rigogliose, le zone boscose occupate da querceti misti a roverella e cerro, i boschi di leccio e di sughera e le grandiose ville, rendevano il paesaggio armonico, privo di forti contrasti tettonici e brulicante di vita.
Il suburbio era un formicolare di gente ed attività, non solo i ricchi patrizi si intrattenevano nelle loro proprietà per banchetti, battute di caccia, festeggiamenti e rappresentazioni teatrali, ma, tutt’intorno, i contadini coltivavano la terra e gli allevatori di bestiame pascolavano le loro mandrie; dato poi che la costruzione di ogni singolo acquedotto richiese molti anni di lavoro, la campagna risultò percorsa e frequentata anche dai tanti operai impegnati nei lavori d’innalzamento delle arcate e dei ponti degli acquedotti.
E se le ville patrizie erano rivestite di marmi preziosi, gli stessi acquedotti avevano una tattilità materica che li rendeva vibranti di sfumature, tante quanti erano i materiali utilizzati per la loro costruzione: il tufo, il travertino, la selce, il mattone costituivano la struttura delle arcate, mentre il cocciopesto era utilizzato per rendere impermeabili le pareti dei canali di scorrimento dell’acqua.
In particolare, il tufo sta a testimoniare l’origine vulcanica del territorio romano, che si riflette sulle arcate degli acquedotti dipinte dai colori terrosi, rese stridule dalle varie tonalità dell’ocra che diventano di un dorato accecante quando il sole romano le trasforma in un’unica fascia luminosa.
I contrasti, dunque, non erano così netti come li percepiamo oggi. Bisogna considerare, infatti, che la componente archeologica instaura un legame profondo con quella ambientale, tanto che questi due aspetti, risulterebbero, oggi, incomprensibili se analizzati singolarmente. Se si leggono gli acquedotti come elementi continui nel paesaggio della Campagna Romana, come riferimenti spaziali ed architettonici, non si può non tener conto che essi erano immersi in una natura rigogliosa.
E dunque, nell’antichità, il territorio attorno a Roma era costellato da molti riferimenti visivi. Se per “riferimenti” consideriamo, però, elementi che:”…posseggono una forma intelligibile, se contrastano col loro sfondo; e se hanno qualche preminenza nella ubicazione spaziale” (Kevin Lynch, L’immagine della città), allora ci rendiamo conto che la definizione deve essere ampliata nel suo significato perché non perfettamente calzante, tenendo presente che possono essere riferimenti anche gli elementi vegetazionali – un albero secolare, una macchia di verde che s’insinua tra il costruito o un rilievo montuoso – non solo, quindi, gli episodi architettonici.
Quando, però, in un’area, seppur vasta, tali riferimenti diventano molti, diminuisce il loro significato, tendendo piuttosto a formare un “tessuto” riconoscibile solo nel suo insieme. Tanto più il tessuto è fitto minore sarà la possibilità di estrapolare un elemento che costituisca una matrice visiva. Solo nel caso in cui due entità vicine si differenzino l’una dall’altra per altezza o dimensione, allora il concetto di riferimento si rafforza e si palesa. Ma è anche possibile che soltanto tra due o più elementi attigui si stabilisca una forte armonia, un perfetto equilibrio tra le parti, per cui, insieme, costituiscono un “micro-tessuto”. Seguendo questa logica ci si rende conto di quanto la campagna fosse fitta di elementi dominanti. Le ville patrizie costituivano dei tessuti preminenti non solo nella loro parte abitata, ma prendendo in esame anche il parco che le circondava e tutti gli edifici secondari sparsi nel verde. Allo stesso modo, analizzando gli acquedotti, non solo relativamente alle arcate ma anche alle piscine limarie, ai castelletti, alle mostre terminali, essi si configurano come degli organismi compatti, come dei veri e propri tessuti che segnano il territorio.
Non è secondario esaminare tali dinamiche relazionali, poiché queste palesano e chiarificano i profondi cambiamenti che avvengono nel territorio. Una concezione “estetica” del paesaggio, che tenga conto delle trasformazioni in continuo divenire, deve necessariamente considerare i giochi di forza che si instaurano tra gli elementi che lo compongono. Tornando, per esempio, al caso di Tor Fiscale, si può notare come il rapporto tra la torre e l’acquedotto, tra il verticale e l’orizzontale, tenda all’equilibrio. Pur essendo la prima alta trenta metri, non mortifica minimamente l’acquedotto più basso, che si sviluppa, invece, in lunghezza e con una conformazione spaziale costituita da pieni e vuoti che gli conferiscono la stessa valenza percettiva. Quando l’occhio osserva lo scorcio dell’acquedotto con sullo sfondo l’innesto della torre percepisce una condizione di stasi; i due riferimenti si bilanciano in un unico partito architettonico.
Il ricco tessuto che si era andato formando nel corso di otto secoli, a partire dalla fine del IV secolo comincia a disfarsi, quando, come accennato in precedenza, i Goti misero d’assedio Roma tagliando i principali acquedotti che rifornivano la città. D’improvviso, quei grandiosi monumenti che avevano reso fiorente Roma diventarono la causa di profondi e negativi stravolgimenti. Se si pensa alla quantità di costruzioni che fondavano la loro ricchezza sull’acqua ed alle trasformazioni che questi edifici subirono per non esserne più riforniti, si può avere un’idea di ciò che si andava delineando. Le grandi terme, i ninfei, le vasche e fontane e tutti gli altri svaghi e servizi a cui una città imperiale come Roma era abituata, all’improvviso non erano più utilizzabili, nessuno più li frequentava. La mancanza dell’elemento vitale li fece cadere in rovina: le terme imperiali cominciarono ad essere invase da arbusti ed erbacce, i preziosi rivestimenti in marmo, le vasche e le anfore ricavate da blocchi di marmi orientali e africani furono asportate e riutilizzate come urne per le reliquie o come fonti nelle cappelle battesimali.
In questo periodo storico non si sarebbe potuta certo percepire la potenza di Roma,ma ne avremmo visto tutto il suo declino, con i simboli della grandezza circondati dal cappero, dalla sassifraga, dalla borracina rupestre, dalla parietaria e dall’ombelico di Venere, a velare e quasi nascondere, per non ricordare, il glorioso passato.
La cittadinanza romana era costretta nuovamente a bere le acque del Tevere, sicuramente migliori rispetto a quelle delle sporadiche fonti superstiti, tutte inquinate a causa dello stato di abbandono delle canalizzazioni. La dipendenza dal Tevere si manifestò in un duplice aspetto, da un lato il fiume alimentò particolari forme di commercio legate alla vendita dell’acqua, dall’altro influì sul ridisegno urbano della città. L’acqua, per essere bevuta, richiedeva lunghi periodi di decantazione in apposite vasche che solo i nobili e le alte cariche clericali possedevano. La popolazione ricorreva, invece, ai cosiddetti “acquaroli” che, nel basso medioevo e nella prima età moderna, costituivano una delle più antiche associazioni di mestiere, la quale aveva il compito di distribuire l’acqua, già purificata, per i Rioni di Roma all’interno di botti trasportate da asini. Ovviamente, il fatto che tutti potessero usufruire di acqua a basso costo, prelevandola direttamente dal fiume, ha sicuramente reso secondaria la necessità di ripristinare gli antichi acquedotti romani rispetto ad altri problemi che affliggevano la città. Inoltre, a partire dal medioevo, la possibilità di sfruttare il Tevere, fece si che le nuove abitazioni venissero costruite lungo il suo corso, determinando, al tempo stesso, lo spopolamento delle aree più alte dell’Urbe, non più servite dagli acquedotti a causa delle demolizioni eseguite dagli eserciti nemici che avevano assediato la città.
La campagna subì così profonde mutazioni, gli acquedotti, che per secoli erano stati fonte di vita, benessere e ricchezza, divennero strumenti di morte. La demolizione di parte delle arcate effettuata per interrompere il fluire ininterrotto dell’acqua fino al centro cittadino non le impedì di scorrere fino alla falla e, quindi, di uscire, liberandosi dalla sezione obbligata dello speco. In questo modo, milioni di metri cubi di acqua si riversarono in vasti tratti del territorio inondandolo e trasformando i pascoli e le zone coltivate in paludi e acquitrini, tanto che l’unico prodotto coltivabile rimase la vite.
L’Agro Romano perseverò a lungo in questo stato di abbandono, a causa dell’insalubrità dell’aria e della pericolosità dei luoghi, frequentati da bande di delinquenti e malintenzionati. Le attività agricole erano misere e sporadici gli interventi di manutenzione dei fossi, degli acquedotti e dei percorsi d’acqua coperti ormai dal giunco e dalla cannuccia di palude. Il solo legame produttivo che univa la città alla campagna era l’estrazione di materiale dalle cave di pozzolana e tufo, presenti lungo i principali assi viari, nonché lo scavo a scopo antiquario. Le arcate degli acquedotti, per gli abitanti di Roma non divennero altro che utile materiale da costruzione; i proprietari dei terreni sui quali passavano, potevano addirittura vendere il materiale dei ruderi a metri o ad arcate, ritenendo gli antichi acquedotti privi di qualsiasi importanza storica o archeologica.
Poiché svuotati letteralmente della loro funzionalità e linfa vitale, gli acquedotti si ridussero, in tal modo, a grandi cave dai conci già tagliati e, quindi, facilmente asportabili. Tale situazione dipendeva strettamente dal fatto che i terreni erano di proprietà di pochi latifondisti e delle autorità ecclesiastiche, che si preoccupavano esclusivamente di riscuotere le rendite senza curarsi delle condizioni dei propri fondi, lasciandoli all’incuria e alla speculazione.
Un ruolo di primo piano venne ricoperto dalla Chiesa che riuscì ad impossessarsi di molti terreni, sia attraverso donazioni che tramite l’acquisto diretto dai contadini, i quali, a causa delle eccessive tasse, erano costretti a cedere le loro proprietà; fenomeno, quest’ultimo, che produrrà quella particolare forma di affitto conosciuta come “enfiteusi”, in base alla quale il piccolo proprietario, esentato dal pagamento delle tasse, poteva lavorare e custodire i terreni versando una quota stabilita all’autorità ecclesiastica che ne era legalmente proprietaria.
L’immagine che si va così delineando della Campagna Romana, oscillante tra il crepuscolare e il decadente, pur carica di nostalgia passatista, è un’immagine forte e suggestiva che si dilata nel corso dei secoli e attira nella zona molti viaggiatori. E’ questo il periodo, compreso tra fine ‘700 e ‘800, che rende Roma la meta preferita della nobiltà e della borghesia europee, grazie anche alla creazione di vere e proprie istituzioni quali il “Grand Tour”, il “Voyage en Italie” e la “Italienische Reise”. I dintorni di Roma rappresentavano, in quegli anni, l’interazione tra archeologia e paesaggio, tra storia e natura, capace di nutrire i viaggiatori colti dell’epoca che cercavano ispirazione per i loro romanzi o scorci suggestivi per i loro dipinti. La natura selvaggia caratterizzata da distese di prati incolti, senza alberi, né arbusti, né cespugli a dare un po’ di colore e vitalità all’immagine, ormai scolorita, dei ruderi degli acquedotti; le capanne dei pastori, i soli abitanti della zona, erano le uniche tracce di un flebile fermento che ancora perdurava. Così, la Campagna Romana, silenziosa e desolata offriva loro proprio quelle sensazioni tanto ricercate.
Ma lo sviluppo non pianificato della periferia romana e la speculazione edilizia sui terreni, iniziati fin dal 1870 quando Roma diventa la Capitale d’Italia, cambiano i dintorni della città. Se fino agli inizi del ‘900 il perimetro della stessa era definito dalle Mura Aureliane e ci si spostava nel suburbio solo per battute di caccia o per frequentare le osterie, dal dopoguerra in poi la campagna comincia ad assumere quei connotati caotici e disordinati che la caratterizzano tutt’oggi. Al di là delle mura non c’è più, come disse il Belli, “er deserto”, ma un paesaggio frammentario, privo di un disegno coerente, anche se, tra le valli rivestite di tufo dorato e le forre che solcano il terreno, tra gli spazi coltivati o lasciati a pascolo, sono ancora ben visibili le tracce della Campagna Romana, dove gli alberi caratteristici come il leccio e la sughera, il rovere, l’olmo e il lauro nelle zone più umide, danno origine a piccoli cunei di macchia non ancora antropizzata.
Ma sono giunti sino a noi anche luoghi nei quali si può ancora rivivere l’atmosfera degli antichi acquedotti. Il Parco dell’Appia Antica è un’area tra le più ricche di storia e archeologia, dove passano ben sette di queste antiche strutture. Anche se il paesaggio è stato profondamente plasmato nel corso dei millenni dall’opera dell’uomo, l’evoluzione geologica e geomorfologia dell’area ha consentito di modellare il territorio. In particolare, è stata l’attività del Vulcano Laziale, con imponenti colate di lava, a determinare gli aspetti peculiari del paesaggio, creando quella “piattaforma” dall’andamento pianeggiante, più rilevata rispetto alle pianure paludose circostanti, sulla quale vennero fatti passare gli acquedotti, che dovevano arrivare nei pressi di Roma ad una quota piuttosto alta per poter servire tutta la città. Tale attività vulcanica, unita all’azione degli agenti atmosferici ed, in particolare, delle acque superficiali, ha permesso la creazione di un terreno dall’aspetto ondulato ed ha creato, in alcuni tratti, numerosi e profondi solchi dovuti all’erosione, separati da strette lingue pianeggianti di terreno. Lo scenario della zona sud-orientale dell’agro romano, si presenta, pertanto, come un ampio tavolato vulcanico solcato da numerosi fossi che vi hanno scavato i propri alvei. Qui, tra i prati e gli anfratti, si ergono grandiose le arcate degli acquedotti, dove, tra le fenditure del tufo, oggi si annidano rigogliose piante spontanee, capaci di svilupparsi anche laddove la fertilità non abbonda e di dare vita ad inaspettate esplosioni di colore. Le rose, i fiori gialli delle bocche di leone, il verde luminoso delle felci, il viola dei capperi e la caparbietà del fico fanno mostra di se sui ruderi, testimonianza dell’ingegno umano. L’imponenza delle rovine dell’acquedotto Claudio è ancora intatta, benché sia attaccata dagli effetti della speculazione edilizia, che ha dato vita ad un tessuto urbano piuttosto eterogeneo, caratterizzato da aree densamente edificate e popolate e da cunei di verde che, nonostante tutto, conservano il loro valore paesistico-archeologico. Nel saggio La mente nera di Piranesi, Margherite Yourcenar, scrive:”…l’immagine della rovina non scatena in Piranesi un’esplosione retorica sulla grandezza e la decadenza degli imperi e sull’instabilità delle vicende umane, ma una meditazione sulla durata delle cose o la loro lenta usura, sull’oscura identità del blocco che continua all’interno del monumento la sua lunga esistenza di pietra”. Mentre osserviamo e ricostruiamo nella mente, ciò che gli acquedotti furono, vale la pena non soffermarsi sui disastri perpetrati dall’insensibilità dell’uomo e dall’incuria, ma fissare piuttosto l’attenzione su quei singoli blocchi di tufo che persistono al loro posto, incuranti del tempo; ammirarne anche semplicemente l’estetica e riscontrare come il corso dei secoli ha favorito la stratificazione di forme, colori, dimensioni che, considerate singolarmente altro non sono se non semplici pietre, ma che giustapposte materializzano un organismo unitario, in cui ogni elemento è inscindibile dall’altro. Ma, non solo ciò che è avvalorato dalla permanenza nel tempo acquista valore, anche la tracce più recenti, quelle che apparentemente deturpano, sono invece testimonianze di esistenze non lontane.
Avendo la mente sgombra dall’immagine della grandezza retorica passata, possiamo allora giudicare, con minore senso critico, una zona, quella del Mandrione, nella quale le dinamiche di interazione tra acquedotti e tessuto urbano hanno fortemente “inciso” l’unitarietà dei massi di tufo.
La via che dà il nome al quartiere era una strada romana di servizio che passava tra le arcate degli acquedotti Claudio e Marcio ed era utilizzata per la manutenzione di questi ultimi. Qui, tra l’altro, troviamo uno dei tratti meglio conservati dell’acquedotto Marcio che non venne intaccato dalle profonde trasformazioni attuate da Sisto V. La conformazione di tale zona comincia a delinearsi nel primo dopoguerra, quando gente proveniente dall’Abruzzo, dalla Calabria e dalla Sicilia si trasferisce a Roma, grazie alle opportunità offerte dal boom edilizio. A questi si aggiungono anche molti romani che abbandonano il centro cittadino a causa degli sventramenti attuati da Mussolini. Facevano, inoltre, parte della comunità anche zingari impegnati nell’allevamento del bestiame e in attività artigianali. Le condizioni di vita di questi disperati non erano delle migliori, mancava qualsiasi tipo di servizio, persino l’acqua era carente, tanto che ci si riforniva alle uniche due fontane del quartiere, si sfruttavano le autobotti assicurate dal Comune o, in altri casi, si prelevava l’acqua dall’acquedotto Felice attraverso canalizzazioni precarie.
In questo brano di città strappato alla campagna, l’acquedotto diventa la struttura portante delle abitazioni che, infatti, sfruttavano lo spessore delle arcate, che raggiungeva i quattro metri, per avere delle mura solide cui addossarsi.
Le baracche, che caratterizzarono quest’area per molto tempo, vennero demolite alla fine degli anni settanta per far posto alla nuova conformazione urbanistica stabilita dal piano regolatore del 1962. Ma camminando per Via del Mandrione, costeggiando le arcate, sono ancora visibili le tracce dell’utilizzazione degli spessi muri in tufo come pareti delle case abusive; si vedono intonaci rossi e celesti, parti rivestite con piastrelle, ovunque fori per fissare strutture in legno o ferro e, ancora, materiali usati per le coperture, come lamiera e coppi; tra i conci antichi di tufo si insinuano, incastonati, moderni forati che definivano i vani delle abitazioni abusive; in alto, tracce di tavelloni usati per i tetti e, ai lati della strada asfaltata, vecchie mattonelle di graniglia costituiscono gli attuali marciapiedi.
Questo scenario, offerto da quell’antica via di servizio, ha costituito l’ambientazione perfetta di molte delle storie raccontate da Pier Paolo Pasolini. Infatti, proprio in questo quartiere, lo scrittore trovò la vita e la vitalità di quella gente di cui amava narrare le storie, dalle quali emerge il degrado sociale della periferia romana, che ancora oggi è possibile ritrovare non solo al Mandrione ma anche in altre zone periferiche.
Se torniamo ora al concetto di “riferimento”, vediamo come la conformazione odierna della campagna, in cui i resti degli acquedotti sono prevalenti, fa sì che tale principio muti e si rafforzi. I ruderi, seppur talvolta maestosi, delle ville, sono secondari rispetto alle monumentali arcate che si stagliano su un paesaggio spoglio, fatto di poche coltivazioni e di verde antropizzato.
Ciò che oggi fa di esse un riferimento visivo è il contrasto con l’espansione mediocre della città, che con i suoi palazzi crea un distacco stridente e nostalgico. Contemporaneamente, però, perdono valore i “tracciati” individuati dagli acquedotti, un tempo estremamente forti perché regolari, dalla forma integra e continua, oggi ridotti a spezzoni, a forme incomplete ed isolate che l’occhio non può percorrere fino al loro stadio conclusivo. A prevalere oggi è lo scorcio paesaggistico, gli antichi acquedotti sono, infatti, il più delle volte osservati da lontano, dalla ferrovia o dalle strade a scorrimento veloce che, li fanno apparire come delle barriere, come degli ostacoli all’unitarietà del territorio.
Avvicinandosi, però, si riscopre la permeabilità, il continuum che si instaura tra una parte e l’altra del breve tratto di natura conservata nelle loro immediate prossimità. E allora, quei ruderi, quegli ammassi di tufo giustapposti e modellati secondo una forma compiuta, rivelano la loro imponenza. Infatti, osservando da vicino i tratti conservati degli acquedotti, la vista si perde, l’occhio non ne percepisce il limite e il punto d’arrivo; la “direttrice” non è più spazialmente una barriera e il concetto di riferimento riacquista tutta la sua pregnanza di significato.
Ancora un altro aspetto emerge e, anzi, si manifesta palesemente: è quello della tridimensionalità. Ad una distanza di pochi metri l’acquedotto non è più un fondale prospettico, una striscia continua che nasconde tutto ciò che c’è dietro, ma è una massa con un suo spessore, una sua profondità, una sua consistenza materica e plastica. Le arcate non appaiono come dei contorni lineari, come delle cornici sul mondo parallelo che le lambisce sul lato opposto, ma diventano un cannocchiale prospettico, un largo passaggio che demarca un confine con ciò che c’è oltre ma che, allo stesso tempo, lo unisce per similitudine di forme e colori. Il solo luogo racchiuso da ogni arcata e dai vuoti laterali delimita uno spazio, un ambiente in se raccolto e definito. Gli acquedotti risultano, così, dei grandi vuoti cui è stata adattata una cornice intorno; degli ambienti legati a tutta l’architettura romana, dominata da un senso di monumentalità e sovradimensionamento.